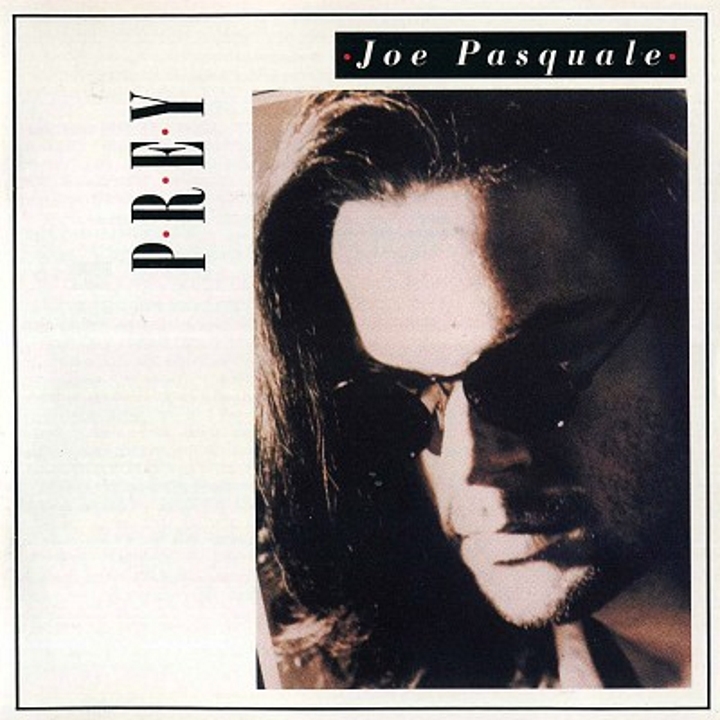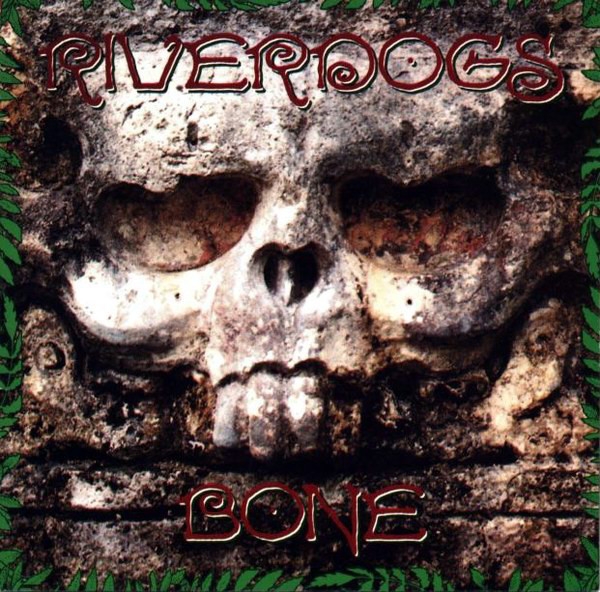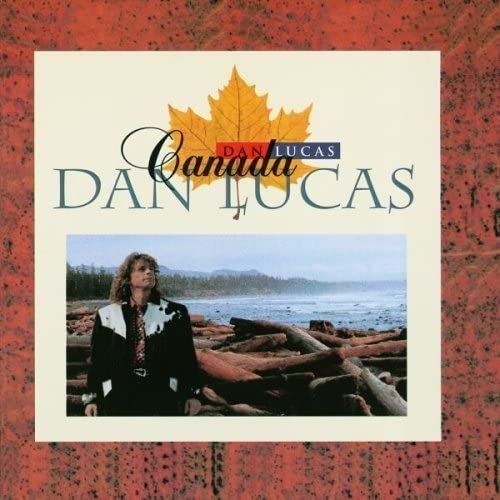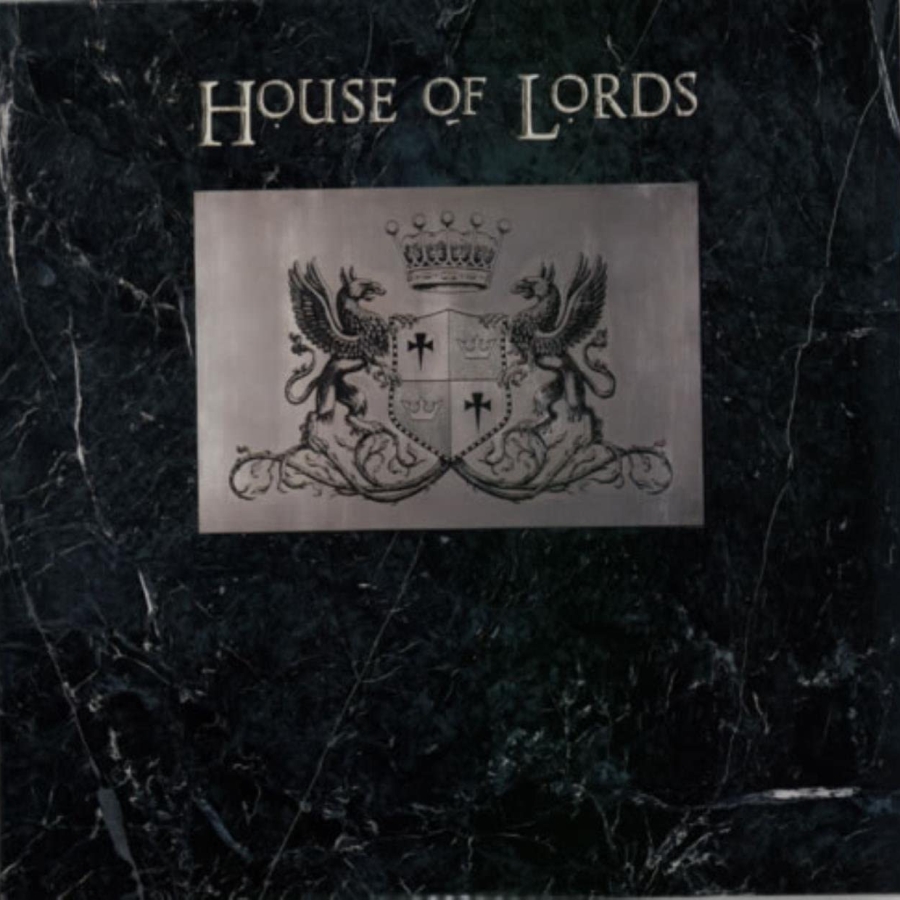LOGIN UTENTE
Registrati a MelodicRock.it

Registrati gratuitamente a Melodicrock.it! Potrai commentare le news e le recensioni, metterti in contatto con gli altri utenti del sito e sfruttare tutte le potenzialità della tua area personale.
effettua il Login con il tuo utente e password oppure registrati al sito di Melodic Rock Italia!
Classici
- Home
- /
- Classici
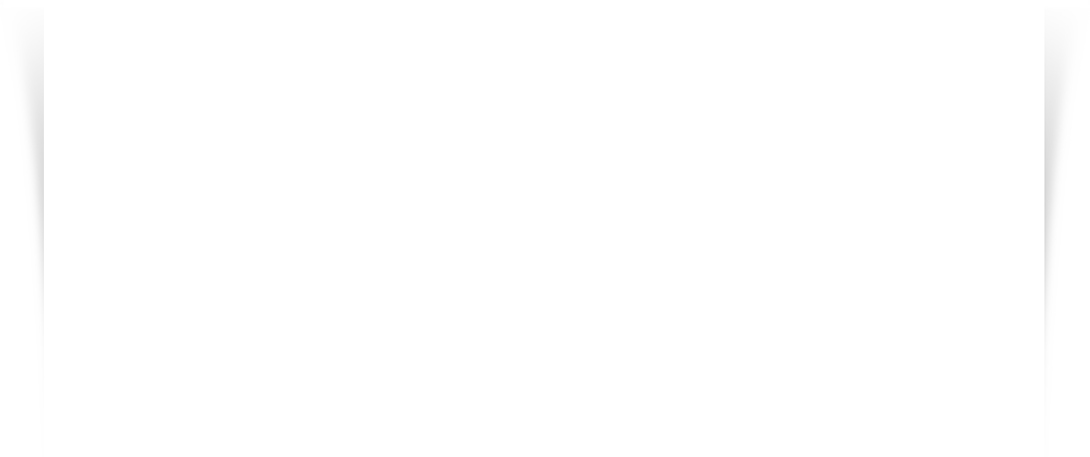
Strangeways – Native Sons – Classico
14 Gennaio 2022 4 Commenti Yuri Picasso
genere: Aor
anno: 1987
etichetta: 2011 Rock Candy
ristampe: 2011 Rock Candy
Perfetto connubio di ispirazione, capacità compositive, padronanza tecnica, condite da una produzione di livello come il genere richiede(va) (rebbe). Questa è la sintesi perfetta del secondo parto degli scozzesi Strangeways, il primo con il talentuoso vocalist americano Terry Brock, chiamato a sostituire Tony Liddle. Lungo l’airplay arriva probo l’istinto della band di scrivere materiale d’impatto, emotivo, puro, raffinato. Pensare che il primo di gennaio questo disco ha compiuto 35 anni, l’impatto viscerale in grado di suscitare rimane inalterato tanto la musica di qualità rimane eterna.
Due parole sui pezzi…
“Face to Face” e “Only a Fool” sono notturne, romantiche ma lontane dal melenso da classifica. Colpisce dritto al cuore l’impasto sonoro ultra definito, merito dell’ottimo lavoro dietro al mixer di John Punter (Slade, Nazareth) svolto ai famosi Powerplay Studios nella provincia di Zurigo. Il groove basso-batteria creato dalla coppia Drummond/Stewart in “Stand Up And Shout” o ancora in
“Empty Streets”, mostra i muscoli morbidi della band con un sound di chitarra leggermente retrò a ricordare il Neal Schon dei primi 80’s. Per “Goodnight L.a.” venne tratto un video a lungo irreperibile sul tubo. Parte col basso che martella sullo stesso giro, accarezzato da synth lievi, per poi aprire al bridge con Brock sugli scudi mostrante tutte le sue abilità nell’estensione vocale intervallato nel chorus da Ian Stewart alla solista con note pronte a squarciare luce nel buio. “Never Going To Lose it” alterna strofe delicate ad un ritornello incisivo, l’esatto opposto di “Where do We go From Here”, entrambe capaci di dispensare sequenze di emozioni e ricordi a flusso continuo.
La sfortuna generale degli Strangeways è stata quella di essere a torto considerata una band molto o troppo vicina ai Journey. Alcuni perimetri artistici possono coesistere , come il timbro di Brock, a tratti una sorta di Steve Perry ipervitaminizzato; o in alcune scelte compositive, ma al medesimo tempo è inverosimile non essere in grado di riconoscere al combo scozzese-americano la propria definita identità artistica che raramente verrà riprodotta con fedeltà da altri moniker. La band due anni dopo pubblicherà “Walk In The Fire”, e, nonostante suonerà come una conferma delle capacità esplosive e fuori dal comune della band , non riuscirà ad entrare in classifica, a causa della solita serie di eventi sfavorevoli. Eccessivamente ai confini del timing temporale perfetto, scarsa pubblicità, e insolite ed ingiustificabili recensioni internazionali che lo definivano un disco di serie B creato da una band di serie A. Dopo poco Terry Brock proverà ad entrare nei Deep Purple, mancando, e gli Strangeways continueranno a pubblicare dischi intimisti lungo i 90’s con Ian Stewart dietro il microfono, ripresi per lo stile da quelli pubblicati dopo la reunion del 2010. Lascio a voi la diatriba su quale dei due sia migliore. Personalmente li metto alla pari e su una ipotetica scala da 1 a 100, entrambe si prendono 95. Il dualismo va a favore di quale dei due ha regalato all’ascoltatore maggiori emozioni introspettive…
Alcuni manifesti musicali, seppur vicini alla perfezione, rimangono per pochi e non entrano in quella che potrebbe e dovrebbe essere cultura popolare. Rimangono, come “Native Sons” insegna, storie di Musica Vera.
Joe Pasquale – Prey – Gemma Sepolta
04 Gennaio 2022 11 Commenti Samuele Mannini
genere: Pop rock/Aor
anno: 1991
etichetta:
ristampe:
Mollaccioni di tutto il mondo unitevi!
Disco veramente eccellente questo qui , certo molti Defender duri e puri staranno già sguainando la spada oppure fuggendo urlando di fronte a tanta melodia popeggiante. Anche io nel 1991 quando, stimolato da una recensione entusiasta, lo comprai, a stento riuscì a raccogliere la mascella di fronte alle note quasi disco dance della prima canzone, risultato? CD nella custodia e polvere a coprirlo per un paio d’anni. Poi il tempo passa, crescendo e venendo esposto a massicce dosi di melodia decisi di riesumare il disco e dare un’altra chance al buon Joe… beh quella volta in effetti non mi parve poi così male ed anzi, andando avanti con gli ascolti viene fuori che questo disco è dannatamente sexy e che… più lo mandi giù e più ti tira su…
Il nome potrebbe trarre in inganno sulle origini. In realtà la nazionalità di origine è francese, ma con un cognome così gli avi di Joe sono sicuramente italici. In fondo, non penso sia poi un caso che certe influenze latine si vadano a fondere nella sua musica, che però è assolutamente riconducibile al pop/rock aor di marca statunitense. Vogliamo definirlo hi tech Aor? Ok, tanto più o meno le coordinate sonore son quelle e la definizione esatta è questione di lana caprina. Quello che realmente è importante è che pezzi come: Believin’ , Paint It Blue , Faith Of An Age e On My Own, sono vere e proprie perle melodiche, interpretate con voce suadente a ammiccante, veri e propri potenziali Hit! Anvedi Pasquale che paraculo che è! Se poi uno va a spulciare il libretto, si capisce benissimo il perché questo disco sia assolutamente irresistibile. Il gotha dell’AoR ha partecipato a Prey. Intanto nelle composizioni c’è la penna di Bruce Gaitsch e se non sapete chi è, peste vi colga. In qualche pezzo compare pure di Diane Warren, senza contare che lo stesso Joe è un autore di categoria superiore. Andate poi a scorrere la lista dei musicisti partecipanti e vi troverete davanti all’olimpo.
Insomma un disco che si colloca nella migliore tradizione soft AoR, ben prodotto ben suonato, ruffiano, ma allo stesso introspettivo. Da tenere in sottofondo, se fate una cenetta intima e romantica e volete fare il fine intenditore, ma anche per fare “l’americano” col finestrino aperto e il vento che scompiglia i capelli.
Insomma….mollaccione si….ma con Nesquik.
Per la reperibilità vi consiglio discogs o ebay in quanto pur essendo una uscita major, non mi risulta essere stato ristampato e quindi il mercato dell’usato è la via più facile per entrare in possesso di questo gioiellino dei tempi che furono.
Giant – Time To Burn – Classico
03 Dicembre 2021 13 Commenti Samuele Mannini
genere: Hard Rock
anno: 1992
etichetta:
ristampe:
Manca poco all’uscita del nuovo disco dei Giant, mi è quindi venuta spontanea una riflessione sull’importanza di questa band per gli amanti delle sonorità hard rock. Pur avendo dato alla luce pochi dischi nell’arco di più di trent’anni di carriera, un disco dei Giant non deve mancare tra quelli da portare sulla proverbiale isola deserta. Si, ma quale? Beh non Promise Land che dei Giant ha poco piú del nome ed un paio di canzoni. III artisticamente invece è molto valido, ma il richiamo dell’epoca d’oro è per me irresistibile, quindi il dilemma si restringe al debut Last Of The Runaways del 1989 ed il secondo Time To Burn del 1992. Data la titanica difficoltà nello scegliere tra i due, che obiettivamente sono dei masterpiece, ho sottoposto l’arduo quesito ai partecipanti del gruppo Facebook di Rock Of Ages. Dopo una serrata lotta all’ultimo voto l’ha spuntata Time To Burn, che mi accingo dunque a mettere nello zaino, destinazione isola di Cast Away.
Qualitativamente rispetto all’esordio non ci sono differenze, onestamente sono due dischi top, possiamo forse parlare solo di un sottile diverso orientamento sonoro, ma son dettagli. Col cambio di songwriting, si è andati verso un leggero indurimento dei suoni e una maggiore attitudine al rock più anthemico e , passatemi il termine, roboante. Il grande pregio dei Giant è che all’interno della scena Hard & Heavy sono stati visti di buon occhio anche da chi duro e puro in quegli anni si rivolgeva a sonorità più estreme. Più volte ho visto Thrasher incalliti e Defenders duri e puri battere il piedino e canticchiare Thunder And Lightning, in virtù di una chitarra tagliente, una ritmica serrata e suoni assolutamente favolosi anche per l’epoca. Sette minuti abbondanti di un southern/blues che cresce elettrico, vibrante e sofferto caratterizzano Chained, la canzone che mi ha fatto innamorare di questo disco. L’anthem di Lay It On The Line ci delizia con la sua potente atmosfera arena rock e ci introduce al singolo Stay e qui due paroline in più bisogna spenderle; potrebbe essere un trattato di come si scrive una canzone rock, ritornello vincente, atmosfera in chiaroscuro e riff di chitarra frizzanti ed ispirati, 10 e lode. Lost In Paradise è un esempio di power ballad da manuale, malinconica e triste, ma soprattutto “cazzuta”, ascoltate il solo di chitarra centrale, passionale e romantico, ma assolutamente non mieloso ne stucchevole. I 30 secondi di Smoulder, in puro Cinderella style, ci introducono la title track, un hard rock roccioso tirato a 200 all’ora, ho sentito definire i Giant Aor……ma non scherziamo per favore. L’amore per la melodia si vede in I’ll Be There (When It’s Over), una canzone che in questo disco forse non spicca, ma che altre band nemmeno si sognano. Save Me Tonight è un mid tempo che poggia su un giro di basso scoppiettante e con un ritornello vincente ed armonioso. Ancora il lato melodico della forza in Whitout You e se vi somiglia vagamente a Brian Adams…… andate a vedere chi l’ha scritta e tutto sarà più chiaro. Now Until Forever è la ballad vera e propria e non ce n’è per nessuno, qui l’accendino lo accendete anche se siete da soli in salotto con lo stereo a palla. Si chiude con l’hard blueseggiante di Get Used To It ed è una ennesima dimostrazione di classe pura.
Quante volte io abbia ascoltato questo disco in loop non saprei proprio dire, probabilmente un centinaio e non sono mai sazio. Questo è quello che distingue un classico da un buon disco, non solo la perfezione sonora e le canzoni, ma il feeling e quel quid che solo pochi hanno. Poi parliamoci chiaro la produzione di Terry Thomas è a livelli eccelsi e paragonare questi dischi alle odierne uscite è veramente impietoso, ma come detto, c’è di più , c’è un mondo dentro questo disco, chi si professa amante dell’hard rock, lo deve e sottolineo DEVE, assolutamente conoscere.
Def Leppard – Pyromania – Classico
01 Dicembre 2021 10 Commenti Giorgio Barbieri
genere: Hard Rock
anno: 1983
etichetta:
ristampe:
Provocazione: non riuscirete mai a quantificare quanto ho odiato questo disco e il singolo “Photograph” e allora perchè, direte voi, adesso addirittura lo recensisci? Semplice, perché dopo la pubblicazione della montagna di zucchero chiamata “Hysteria”, questo “Pyromania” mi sembrò un album di death metal!
E’ innegabile che la band fosse in stato di grazia, che molta della musica e degli arrangiamenti fossero ancora farina del loro sacco, ma quando un Re Mida come Robert John “Mutt” Lange (ricordiamo il suo lavoro oltre che con i Leppard, anche su “Back in black” degli Ac/Dc e “4” dei Foreigner, nonchè con Shania Twain, Bryan Adams, The Cars, Michael Bolton, Nickelback), si mette al lavoro su un album, lo deve giocoforza adattare a quella che è la sua idea di suono, deve poter metter mano e voce su come le canzoni devono progredire e su come la band deve eseguirle, fino a diventare il sesto uomo della band e così “Pyromania”, divenne il primo, grande successo dei Leppard, che, ad un’orecchio attento, non era sfuggito ci provassero già dal primo album con “Hello America”, quindi in maniera più palese con i singoli di “High’n’dry”, ma fu con “Photograph”, “Foolin'”, “Rock of ages”, “Rock rock (til you drop)” e “Too late for love”, che i cinque ragazzi di Sheffield fecero saltare il banco. Questo spostamento più accentuato verso sonorità sempre più melodiche, fece sì che la band potesse raggiungere picchi di popolarità inusitati degli States, arrivando a suonare tre volte al Forum di Los Angeles e addirittura davanti a quasi 60000 persone per la data di San Diego, arrivando ad un totale di 112 date, mai più eguagliato durante l’anno solare neanche nel 1988 a supporto di “Hysteria”, mentre in patria la loro fama stentava a decollare, dato che in terra d’Albione l’amore per la nwobhm era ancora vivo e vegeto, ma sarebbe stata solo una questione di tempo e quando il pubblico inglese e più in generale europeo, me compreso, si rese conto della potenzialità dell’album che tutto sommato era il giusto compendio tra la ruvidezza della prima fase e l’edulcorazione che i Leppard volevano a tutti i costi, anche nel vecchio continente “Pyromania” iniziò a funzionare, vendendo circa sei milioni di copie nel solo anno della sua pubblicazione.
La grinta non mancava certo al platter, già dall’opener “Rock! Rock! Til you drop” che sa molto di Ac/Dc, sia per la voce di Joe Elliot, che per gli assoli e i riff, si capiva che i Def Leppard non avevano certo mollato gli ormeggi come successe poi con “Hysteria”, ma che il loro incedere voleva essere energico e melodico al tempo stesso, forse anche grazie agli ultimi colpi di coda di Pete Willis, che in preda a i fumi dell’alcool, venne licenziato durante le registrazioni e sostituito con l’ex Girl Phil Collen. Di “Photograph” è quasi inutile parlare col suo riff riconoscibile a centinaia di chilometri di distanza e con la prestazione di Joe Elliot ancora di prim’ordine, prima di finire nel mediocre già in alcune parti del fortunatissimo successore e nonostante alcuni problemi alle corde vocali proprio durante le sessioni di registrazione; anche dei brani successivi è quasi inutile discutere, data la grandissima notorietà acquisita, ma è giusto citare i pezzi che più restano nell’ombra dei colossali singoli e così anche “Stagefright”, col suo incedere incalzante urla la sua presenza, prima di lasciare il posto alla commovente semi ballad “Too late for love”, degno seguito di “Bringin’on the heartbreak”, che però, permettetemi, nelle sue atmosfere e i suoi passaggi di chitarra, non certo nell’incedere, ricorda un altro grande pezzo storico della nwobhm, ossia “Remember tomorrow” che non penso ci sia bisogno di dirvi chi la suoni…altro pezzo elaborato e non certo scontato è “Die hard the hunter”, che se non fosse per i suoi cori polifonici a-la Queen e il sintetizzatore, sarebbe l’ennesimo tributo alle nebbie britanniche e con un testo sulle conseguenze della guerra in Vietnam, soprattutto sulla psiche dei veterani, a mio parere l’highlight dell’album, il giusto compendio tra melodia e vigore con assoli da brividi! La seconda facciata, per chi ha il vinile, si apre con due singoloni come “Foolin'” e “Rock of ages”, il primo aperto dal classico arpeggione che da il là ad un pezzo di sicura presa, che vive di stop e ripartenze, il secondo, aperto dal campanaccio che sa tanto di States, come in effetti è tutto il pezzo che è una vera e propria dichiarazione d’intenti, con “Comin’ under fire” si ritorna su territori più hard, anche se il brano rimane un pò nel limbo, non decollando e restando piuttosto anonimo rispetto al livello alto delle rimanenti canzoni, i Leppard si riprendono subito con “Action! Not words”, brano ancora vicino all’energia degli Ac/Dc, a parte la slide guitar finale, la canzone, sia come testo (si parla di girare un video con belle ragazze di contorno), sia come andamento, si svolge in un tosto hard-rock’n’roll, quindi la chiusura affidata a “Billy’s got a gun” che ci riporta in territori hard’n’heavy nonostante i classici cori inseriti nel bridge e di nuovo si riaffacciano le brume della nwobhm, soprattutto per quanto riguarda il testo che parla di un certo Billy, della sua pistola e di cosa lo spinge a fare la suddetta arma, una sorta di storia di strada ripresa molti anni dopo dagli Skid Row in “18 and life”, mentre musicalmente il brano si dipana in un ottimo hard ai limiti del metal come lo era inteso a quei tempi, curiosa la chiusura affidata ad un campionamento futuristico, che fa quasi da apripista alle atmosfere patinate del pluripremiato successore.
Non potevo limitarmi ad un mero commento per un disco del genere, mi è bastato lasciare i freni e le parole sono uscite da sole. Quando un album come questo ha accompagnato una parte della nostra gioventù, non si può fare a meno di rilasciare le emozioni fino al limite della nostalgia, con la consapevolezza di aver vissuto quel periodo, guardando sempre avanti, ma non dimenticandosi mai delle nostre radici che crescono anche da qui!
Tyketto – Don’t Come Easy – Classico
17 Novembre 2021 8 Commenti Samuele Mannini
genere: Hard Rock
anno: 1991
etichetta: Rock Candy (2016)
ristampe: Rock Candy (2016)
La Geffen, negli anni d’oro, ha avuto in mano veramente il gotha dell’ hard rock più o meno melodico, naturalmente prima di virare a 180° e cominciare a spingere verso lidi musicali diversi, abbandonando uno ad uno i gruppi che dall’ 86 in avanti, avevano dato lustro e valanghe di soldi all’etichetta. Bisogna però ammettere che come casa discografica ha sempre fatto le cose in grande; così fu anche per i Tyketto, mettendo a disposizione un produttore del calibro di Richie Zito e visto che il gruppo ne era sprovvisto, anche un fine arrangiatore e sublime tastierista quale Alan Pasqua, non certo soluzioni al risparmio per una band al debutto. Infatti, ai tempi dell’ uscita di questo Don’t Come Easy, dei Tyketto non si era minimamente sentito parlare. L’unico membro con un minimo di notorietà e curriculum era infatti il dotatissimo singer Danny Vaughn proveniente dagli Waysted. Di Brooke St James (chitarra), Jimi Kennedy (basso) e Michael Clayton (batteria) io almeno, non avevo mai sentito parlare. Anche in tempi pre internet la stampa specializzata non mancava di certo, ma la notizia di questo gruppo, arrivò improvvisa ed estremamente gradita. Non ricordo chi curò la recensione su Flash e Metal Shock , ma io andai di corsa a procurarmi il vinile che, ancora oggi, dopo un milione di passaggi mi procura immense soddisfazioni sonore.
Tanto per cominciare, Danny è uno che con quella voce farebbe faville anche se cantasse le istruzioni di un frullatore, ma sinceramente anche a livello strumentale siamo di fronte ad una prova di caratura superiore persino alla già alta media dell’ epoca. Infatti, quando parte il giro di Forever Young, è subito amore. Mi ritengo fortunato ad aver vissuto a pieno quei 5/6 anni magici, dove questo genere ha avuto il massimo splendore artistico e commerciale che sembrava destinato a durare in eterno e che in molti, anche inconsciamente, abbiamo dato quasi per scontato, piangendo lacrime amare appena un annetto dopo l’uscita di questo disco. Wings e Burning Down Inside per esempio mi rimandano immediatamente alla spensieratezza di quegli anni, sempre in giro con lo walkman di ordinanza sparato a manetta. Seasons e la delicata ballad Standing Alone, ricordano le prime passioni amorose giovanili con i loro struggimenti che parevano cosi importanti, ahhh…. beata giovinezza. Rock And Roll di alta scuola da gustare appieno in: Lay Your Body Down, Walk On Fire, Nothing But Love e Strip Me Down ci davano la ferma consapevolezza di saperla più lunga degli altri in fatto di musica. Che dire infine della conclusiva Sail Away? Mi faceva letteralmente viaggiare immerso in quelle sonorità, a bordo della mia immaginaria decappottabile sulle assolate higway americane.
Difficile da parte mia affrontare il discorso meramente artistico, quando sono così travolto dalle emozioni e dai ricordi. Mi rendo conto infatti, che per chi non ha vissuto in diretta questa musica sia difficile capire queste mie introspezioni, ma insomma, che devo dire, per i canoni del genere il disco è semplicemente perfetto, quindi disquisire del lato tecnico mi sembra oltremodo superfluo. Ditemi piuttosto se ascoltandolo non vi sale un sottile brivido lungo la spina dorsale e vi si stampa in faccia un obliquo sorrisetto; ecco, proprio quel sorrisetto è la perfetta sintesi di questo disco, anzi di una intera epopea musicale qui perfettamente racchiusa.
Riverdogs – Bone – Gemma Sepolta
11 Novembre 2021 0 Commenti Samuele Mannini
genere: Hard Rock
anno: 1993
etichetta:
ristampe:
Blue Murder – Blue Murder – Classico
02 Novembre 2021 6 Commenti Samuele Mannini
genere: Hard Rock
anno: 1989
etichetta: Rock Candy 2013
ristampe: Rock Candy 2013
Se mischiare un acido con una base può generare effetti spettacolari, è anche vero che di solito è un effetto di breve durata. Così fu anche per la collaborazione tra John Sykes e David Coverdale che generò un caposaldo dell’hard rock quale 1987 ( recensione QUI ), ma non durò nemmeno fino all’uscita del disco nei negozi, tant’è che gli Whitesnake andarono in tour con una formazione totalmente stravolta rispetto all’ellepì. Sia quel che sia, le cronache gossip dell’epoca sproloquiarono non poco sulle vicissitudini tra Sykes e Coverdale alimentando le voci sui dispetti reciproci tra i due, con le varie prese di posizione per l’uno o per l’altro. Quello che però pare certo, è che entrambi fossero delle discrete “teste di ferro”, con grande feeling artistico, ma zero compatibiltà caratteriale.
La storia ha però dimostrato che Sykes è sicuramente un raffinato compositore e ne darà ampia prova su questo Blue Murder. Fatta la sua gavetta in patria con i Tygers Of Pan Tang, poi con i Thin Lizzy ed infine con gli Whitesnake, riuscirà a condensare queste esperienze, arricchite con la sua classe, sfornando un album granitico, che a mio modesto parere va considerato una pietra angolare di questo genere. In questo progetto viene accompagnato dal virtuoso delle quattro corde Tony Franklin (proveniente dall’esperienza col duo Page/Rodgers nei The Firm), e dall’uomo il cui cognome è sinonimo di drumming, ovvero Carmine Appice. Dopo aver provinato diversi vocalist, tra i quali Ray Gillen (futuro Badlands), la scelta di far ricoprire allo stesso Sykes anche il ruolo di vocalist ci ha fatto apprezzare anche un notevole talento canoro davvero sorprendente.
Il risultato sono le nove storie che compongono l’album, storie noir, quasi oscure a volte struggenti in bilico tra rabbia e malinconia.
Storie dicevo che vanno ad esplorare diversi filoni narrativi. Il filone notturno e della rivolta, con la potente Riot che ci narra della fuga di un uomo accusato di un crimine che fugge attraverso una città in tumulto immersa nella notte per salvare la sua vita . Un rullo di tamburi ci introduce Blue Murder, sempre atmosfera notturna, ai limiti dell’heavy metal, qui si dà la caccia ad un vero criminale che, ferito, lotta per la sua vita. Anche in Billy c’è la notte ed una fuga del protagonista, accompagnata da un cesello di chitarra e basso di caratura superiore, fino a giungere al tragico epilogo, ovvero la morte.
Il secondo filone è quello storico . Valley of the Kings, orientaleggiante anche nella musica, narra della costruzione del monumento funerario del faraone, che costerà enormi sacrifici al suo popolo, la trasposizione anche musicale è perfetta sia per resa che per atmosfera. Altra storia orientaleggiante sia per musica che per trama è Ptolemy, dove si respira un aria mediorientale e che ci racconta la disavventura di un cacciatore di tesori….storie allegre in questo disco?… Nemmeno l’ombra.
Il terzo filone narrativo è quello dei sentimenti e parte con Sex Child, lyrics whitesnakiane su struttura zeppeliniana, praticamente il top della cultura hard rock di matrice british. Jelly Roll, parte acustica, quasi country, ma le atmosfere cambiano progressivamente seguendo la storia di un amore finito a cui il protagonista non si rassegna e di conseguenza la musica diventa più languida, trasformando la spensieratezza iniziale in un triste epilogo…… Geniale. La mega ballad di rito è Out Of Love ed è la naturale alter ego di Is This Love degli Whitesnake, nei quasi settr minuti di lunghezza si rappresenta infatti il lato triste dell’amore; inutile negare le somiglianze musicali tra le due, perché la penna di Sykes è ben presente su entrambe e quindi mi sembra cosa più che naturale. Ultima song del lotto è Black Hearted Woman, inutile tradurre il titolo è una storia che non finisce bene nemmeno in questo caso, mentre le atmosfere sono dichiaratamente quelle di Children Of The Night….beh ovvio visto che la mano è la stessa.
Insomma, qui si parla di un disco che non è semplicemente una rivalsa contro la cacciata di Sykes dagli Whitesnake, ma un completamento ed un passo avanti nella carriera di un virtuoso della chitarra , un’ottimo compositore nonché singer molto dotato. Il disco naturalmente, visti gli interpreti, è suonato divinamente e pur non essendo tra le migliori produzioni di Bob Rock la resa è comunque alta ed assolutamente imparagonabile ai miseri standard odierni. Unica pecca, una copertina in stile piratesco, veramente fuorviante rispetto alla musica proposta, oltre che di una pacchianeria inspiegabile. Inspiegabile anche il fatto che la Geffen smise ad un tratto di promuovere l’album alla soglia del disco d’oro, relegando i Blue Murder ad un ruolo di secondo piano nel rooster dell’etichetta e compromettendo in gran parte l’uscita del secondo disco che fu infatti un flop, causando la fine prematura del progetto. Uno dei tanti crimini artistici delle major dell’epoca.
Dan Lucas – Canada – Gemma Sepolta
22 Ottobre 2021 6 Commenti Samuele Mannini
genere: Aor
anno: 1992
etichetta: Comand Record (2007)
ristampe: Comand Record (2007)
In tutte le questioni che riguardano la magia c’è sempre una parola chiave. La famosa parola magica che attiva il processo trasformatore dell’ordinario in straordinario, dall’ Abracadabra, all’Apriti Sesàmo!…. Nella musica, che poi è senza dubbio una forma di magia, questa parola magica è Canada, terra sconfinata e ancestrale dove ogni genere musicale trova la sua sublimazione e se parliamo di AoR e rock melodico, l’eccellenza totale. Può persino trasformare un tedesco natio della ex DDR, di nome Lutz Salzwedel in Dan Lucas e sfornare un disco che è una vera gemma assoluta.
L’occasione per recuperare questo disco è venuta dalla recente uscita del nuovo lavoro di Dan Lucas ( Recensione QUI ). Devo ammettere che fin da quando ebbi occasione di leggere su Flash nel lontano 1992 la recensione di Canada , mi misi disperatamente alla ricerca del CD, ma senza riuscire a trovarlo in nessun luogo. Questo nel tempo sedimentò le mie convinzioni Che Dan Lucas fosse un semisconosciuto Canadese che incideva su una etichetta (Marlboro Music) destinata soltanto alla distribuzione locale e chiusi li la faccenda. Numerosi anni dopo grazie a Discogs ebbi modo di mettere le mani su una ristampa e scoprire anche molte verità su questo Canada. In primo luogo la magia era venuta talmente bene che in molti ignoravano la vera nazionalità del buon Dan. Secondo, la Marlboro Music in realtà era una etichetta tedesca semi illegale che sfruttava il marchio delle note sigarette senza avere minimamente licenza per farlo, temo che questo fatto ne abbia ostacolato non poco la diffusione all’epoca. Si, perché questo disco non ha nulla di europeo, è canadese fino al midollo, si respira la magia dell’incontaminato nord america dalla prima all’ultima nota e credetemi, per un’amante del rock melodico è un vero e proprio bengodi totale.
Se come si dice, il buondì si vede dal mattino, quale migliore inizio di Someone’s Girl? Melodica con irresistibile refrain e atmosfera vagamente Foreigner. Wild Wild Wild è un rock che ti fa battere il piede con la sua semplicità e le tastiere hi tech. L’apoteosi arriva con Canadian Dream,probabilmente il brano più famoso di Lucas e qui c’è veramente la summa dell’Aor, echi boltoniani si fondono con un ritornello pieno di pathos dove la voce di Dan va a toccare vette da brividi, per chi come me ha avuto la fortuna di visitare quel paese, questa canzone è un vero e proprio viaggio. Con Hold On Me si tira un po’ il fiato grazie ad un mid tempo di ispirazione John Waite periodo No Brakes. Over the edge è anthemica e ritmata e contrappunta la rilassatezza della seguente Hide In The Night. Alziamo i giri con The Fire, energetica e rinfrescante, che sarebbe perfetta per una colonna sonora anni 80. Into The Night è blueseggiante e trascinante, mentre la lenta e westcoast I’m Sailing è semplicemente deliziosa. Con Coming Home si tornano a sentire le influenze Foreigner. Poi…… e poi c’è il pezzo che ti spiazza alla grande, nove minuti e mezzo di una suite con partiture progressive/pomp che ti aspetteresti da un Mangold o un Giuffria, ma come detto l’incantesimo ha funzionato alla grande e The Movie ne è la prova, un bignami che racchiude e condensa tutta la magia del disco.
Ecco, Canada potrebbe finire anche qui e già dovremmo gridare al miracolo, ma Dan ha fatto le cose veramente in grande e ci regala una cover di Hot Stuff che avrebbe fatto ballare la stessa Donna Summer, a cui segue Heart Of America (usata pure nei commercials di McDonalds), ed una versione alternativa di Canadian Dream.
Per farvi sbrodolare ancora di più, nella ristampa sono presenti altre cinque! bonus track con partecipanti i Loverboy e Robin Beck , mio Dio che brividi su If You Need Me Tonight quando Dan e Robin duettano…..
Questo non è un consiglio per gli acquisti; è un imperativo categorico, non opponete resistenza alla magia e lasciatevi guidare in questo viaggio irripetibile.
House Of Lords – House Of Lords – Classico
22 Settembre 2021 7 Commenti Samuele Mannini
genere: Hard Rock/Aor
anno: 1988
etichetta: Axe Killers 2000, Music On CD 2013
ristampe: Axe Killers 2000, Music On CD 2013
Se studiassimo l’epopea musicale rock come un libro di storia, gli House Of Lords sarebbero sicuramente un capitolo da approfondire con la massima attenzione, perché rappresentano la sublimazione del percorso artistico di un grande tastierista e la perfetta fusione tra la maestosità del pomp rock keyboard oriented e l’hard rock scintillante di matrice più marcatamente chitarristica che spopolava negli Usa di fine anni 80.
La genesi del gruppo arriva come evoluzione dei Giuffria che con l’album omonimo del 1984 e il successivo Silk + Steel nel 1986 stavano traghettando il pomp rock di marca Angel nei tempi moderni, la scintilla definitiva fu fornita da Gene Simmons che aveva appena fondato la sua personale etichetta discografica e cercava un gruppo a cui fare da pigmalione per lanciarlo in orbita verso il successo. Prima mossa il cambio del moniker, House Of Lords infatti garantiva una magniloquenza ed una presa senza dubbio superiore e Simmons ha sempre avuto l’occhio lungo sul marketing, inoltre furono messi a disposizione della band una serie di songwriter di qualità e venne trovato un equilibrio tra la ridondanza tastieristica di Giuffria e l’impeto da guitar hero del finora sotto utilizzato Lenny Cordola. La sezione ritmica venne affidata a Chuck Wright che già aveva collaborato con Giuffria, mentre alle pelli venne arruolato Ken Mary, una vera e propria garanzia di tecnica e performance. Ultimo colpo di teatro di Gene la rimozione per chissà quali motivi (gli annali hard & heavy di quei tempi erano più ricchi di gossip di novella 3000) di David Glen Eisely a favore dell’ emergente James Christian, tra l’altro dotato di timbrica estremamente simile al predecessore, ma con una attitudine più al gorgheggio di matrice Plant/Coverdale. Affidata la produzione ad Andy Johns i Giuffria 3.0 erano a questo punto pronti sulla rampa di lancio.
Ammirato il logo regale incastonato in pregiato marmo scuro della copertina ed appoggiato il disco (nel mio caso specifico) sul piatto, ecco che parte la magia di Pleasure Palace, intro pomp old school ed hard rock rovente arricchito da cori da urlo. Si prosegue con l’hard rock melodico di I Wanna Be Loved, catchy e anthemica per arrivare ad uno degli episodi più alti del disco ovvero Edge Of Your Life, sofferta e melodica, ma dotata di una classe quasi altezzosa. Ricordate il duetto voce chitarra di Made In Japan dei Deep Purple? Ecco solo dei ‘pazzi’ potevano pensare di mettere una cosa del genere in un disco e naturalmente gli House Of Lords lo hanno fatto in Lookin’ For Strange, pezzo che sembra una jam session di geni. Chiude il primo lotto la splendida ballad Love Don’t Lie, scritta e già edita da Stan Bush e se non vi si stringe il cuoricino qui, potrei ricorrere ad una metafora di Buffoniana memoria. Slip Of The Tongue è il classico arena rock scintillante, mentre Hearts Of The World è epica e affilata. Più ancorata alle radici pomp è Under Blue Skies, con importanti strutture tastieristiche ed un ritornello da urlare a squarciagola coi pugni levati al cielo. Gli ultimi due colpi in canna del disco sono Call My Name, hard rock melodico perfetto per le esibizioni live e la ballad Jelous Heart di pregevole fattura, se per caso conservate dei dubbi sull’eccelso buon gusto di questi musicisti, ascoltate l’arpeggio iniziale di Cordola e godetevi lo spettacolo.
Il disco pur se scarsamente supportato dall’attività live, ebbe un discreto successo e fu seguito da un’altro pezzo da novanta come Sahara e successivamente da Demons Down che formano un trittico eccezionale che ben poche band possono vantare. Il percorso successivo all’uscita di Giuffria dalla band continua fino ai giorni nostri con alti e bassi, ma mi sento di poter dire che le vette dei primi tre album restano a distanze siderali.
In estrema sintesi un caposaldo del rock da possedere assolutamente.
Shark Island – Law Of The Order – Gemma Sepolta
19 Settembre 2021 2 Commenti Samuele Mannini
genere: Hard rock
anno: 1989
etichetta: Bad Reputation 2010
ristampe: Bad Reputation 2010
Sono passati molti anni da quando Richard Black, leader degli Shark Island, era il Re della Strip di L.A. ed a seguito della stampa del loro primo album autoprodotto S’cool Bus facevano live ogni sera. Per prima cosa scordatevi di recuperare il debutto perché esiste solo su vinile impot dagli Usa e costa un rene, secondo rimarrete forse stupiti che una band rimasta tutto sommato nell’underground avesse un seguito di un certo tipo. Ai loro concerti infatti si narra che fossero spesso presenti membri di altri act ben più celebri fra i quali i Ratt, Skid Row ed udite udite un giovane Axl Rose che, sempre secondo la leggenda, pare abbia ispirato molte delle proprie posture live proprio pescando dal buon Richard. Insomma Gli Shark Island ai tempi d’oro avevano un nome di un certo pregio nella scena losangelina che si apprestava a sferrare i suoi colpi migliori proprio in quegli anni.
Naturalmente nella storia della band non mancano di certo le varie beghe contrattuali con le major dei tempi, in primis la A&M, che voleva mettere sotto contratto Richard Black come solista, dopo varie vicissitudini si arriva quindi alla Epic, che consente a questo album di vedere la luce, salvo poi non curarsi affatto della promozione , cosa molto di moda a quei tempi (chiediamoci poi come mai pur con fior fiori di band in giro, l’hard rock sia andato incontro al declino).
Comunque sia, questo Law Of The Order, è un lavoro che si colloca perfettamente nella sua epoca, costantemente in bilico tra l’hard rock “da classifica” ed il class metal più muscolare. La partecipazione al songwriting di Jack Ponti conferisce la classica attitudine catchy al disco, anche se a mio giudizio è forse meno condizionante rispetto ad altre collaborazioni, vedi ad esempio i Baton Rouge. Probabilmente è proprio il timbro vocale del buon Black , ruvido e graffiante, ad indurire un po’ il sound e a rendere meno smielati anche i pezzi più soft; fatto sta che il disco avrebbe le caratteristiche per piacere un po’ a tutti, ma in un’epoca di schieramenti ideologici ( vi ricordate le mazzate che volavano tra thrashers e glamsters ?), forse non fu un vantaggio commerciale.
Tra i pezzi più riusciti vorrei citare la potenziale hit ( ed unico video passato anche su videomusic) Paris Calling col suo irresistibile refrain, la scatenata Shake For Me e l’azzeccato mid tempo Somebody’s Falling che vede come co autore Dave Sabo. Per le orecchie abituate a sonorità più robuste consiglio la quasi Heavy Passion To Ashes. I più romantici troveranno pane per i loro denti nella power ballad Why Should I Believe, intensa e passionale. Interessante , almeno a mio parere, il rifacimento in chiave hard del pezzo dei Fleetwood Mac The Chain.
Come ampiamente anticipato il disco non ebbe successo e dopo l’esperienza nel raffazzonato progetto Contraband il gruppo si sciolse per poi ritornare con due album rispettivamente nel 2006 e 2019 con coordinate sonore abbastanza diverse, ma a mio gusto, comunque da ascoltare. Per i nostalgici della golden era invece non resta che accaparrarsi questa chicca e crogiolarsi cantando a squarciagola l’evertiaiaiaime di Paris Calling.