LOGIN UTENTE
Registrati a MelodicRock.it

Registrati gratuitamente a Melodicrock.it! Potrai commentare le news e le recensioni, metterti in contatto con gli altri utenti del sito e sfruttare tutte le potenzialità della tua area personale.
effettua il Login con il tuo utente e password oppure registrati al sito di Melodic Rock Italia!
Ultime Recensioni
- Home
- /
- Ultime Recensioni
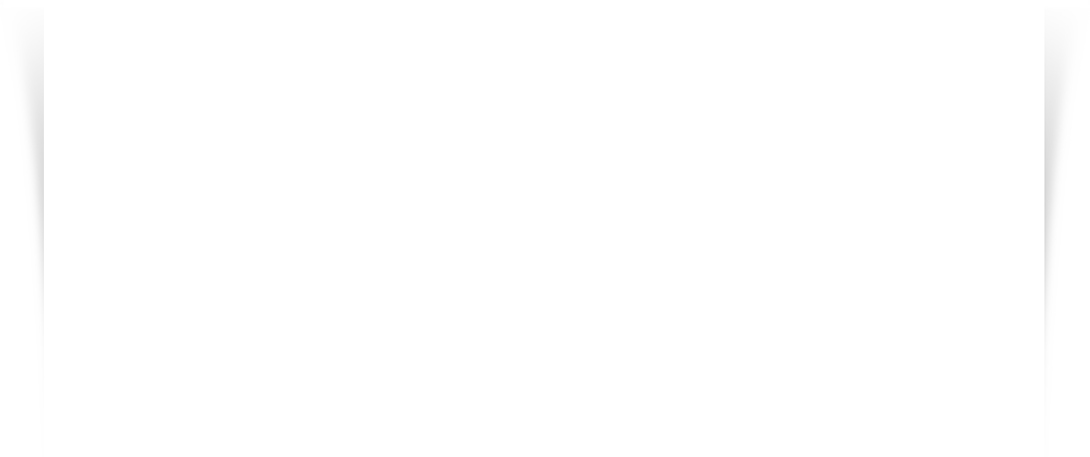
Smoking Snakes – Danger Zone – Recensione
21 Febbraio 2024 0 Commenti Alberto Rozza
genere: Sleaze
anno: 2024
etichetta: Frontiers
Per gli amanti dello sleaze metal, ecco in uscita il nuovo album degli svedesi Smoking Snakes, verace e frenetico come la maggior parte dei prodotti scandinavi aderenti a questo genere.
Partiamo in grande stile con “Angels Calling”, un vero e proprio inno in stile W.A.S.P., sia per trasporto che per timbrica vocale, che mette subito in chiaro quello che la band vuole e pretende dalla propria musica. “Sole Survivors” si presenta con una coralità vocale trasportante e una ritmica cadenzata e gradevole. Ci carichiamo con la poderosa “Run For Your Life”, piacevolissima ma non molto originale, sia per intenzione che per testo, così come la successiva “Lady Luck”, orecchiabile ma nel complesso “già sentita”. Voce graffiante e un certo tipo di ritmica la fanno da padrone: “Excited” è un tributo in tutto e per tutto alla carriera degli W.A.S.P., in questo caso al limite dell’imitazione vera e propria, così come “Restless And Wild” ha qualcosa nell’intenzione e nel testo di molto simile al periodo “Crimson Idol” (addirittura si inizia parlando di “See my face in the mirror”, chiaro richiamo all’album sopracitato). “Sorrow, Death And Pain” prosegue con questo andazzo, citazione o plagio è difficile da capire, ma l’impronta e l’ispirazione sono molto chiare. Globalmente coinvolgente e corale, “There Is No Tomorrow” piace e trascina, fa venire voglia di cantare insieme alla band; allo stesso modo “Who Am I”, tenebrosa e oscura, ma dal gusto interessante. “We Are Alive” non lascia il segno, incastrandosi senza problemi nella trama di questo lavoro. Arriviamo alla conclusione sulle note di “Rocking To The Morning Light”, canonica e decisamente inquadrata nel mood della band, e non ci resta molto da dire su questo album degli Smoking Snakes: influenze ben definite e fin troppo rintracciabili, originalità non propriamente azzeccata, ma tutto sommato un gradevole ascolto, che però troppe volte rimanda ad altre band.
Honeymoon Suite – Alive – Recensione
15 Febbraio 2024 4 Commenti Denis Abello
genere: Melodic Rock / Pop Rock
anno: 2024
etichetta: Frontiers Music Srl
Ancora una volta sotto il tetto di casa Frontiers tornano in pista i canadesi Honeymoon Suite.
Figli dell’epoca d’oro del genere nel 1984 pubblicano l’album omonimo dal discreto successo che verrà bissato dal successivo The Big Prize del 1986, forse l’album più rappresentativo della band. Forti di un sound che mescola abilmente melodie d’impatto di puro melodic rock con uno stile pop altamente radiofonico assaporano un buon successo in patria senza però arrivare mai al “forse meritato” grande salto nel resto del mondo.
Dopo gli anni ’90 e i primi 2000, travagliati per tutto il genere, ma per gli Honeymoon Suite forse ancora di più con differenti cambi di formazione nel ‘2007 la band torna con la formazione storica al completo che vede Johnnie Dee alla voce, Derry Greham alle chitarre, Dave Betts alla batteria, Gary Lalond al basso e Ray Coburn alle tastiere e l’anno successivo da alle stampe l’ottimo Clifton Hill.
A questo punto Ray Coburn lascia il posto alle tastiere a Peter Nunn, attuale tastierista della band, ma è chiaro che, anche se i tempi d’oro sono andati, la band sa ancora il fatto suo.
2019 e il ritrovato e rinnovato quintetto si mette a lavorare con il produttore “compaesano della band” Mike Krompass (Steven Tyler, Theory of a Dead Man, Smash Mouth) dando alla luce due singoli Tell Me What You Want e Find What You’re Looking For che riportano i riflettori sulla band.
Arriviamo così al 2024 e a questo Alive che, per chi se lo stesse chiedendo come me, incide su disco anche i due ottimi singoli usciti nel 2019 e 2020 e che per ora da che mi risulti non godevano di una pubblicazione fisica ufficiale! Chi ha apprezzato questi due singoli sa già quindi potenzialmente cosa aspettarsi da questo lavoro ed i nostri per fortuna non tradiscono, complici ancora della collaborazione con Mike Krompass.
Infatti la decina di pezzi che compongono questo lavoro non tradiscono le radici della band da ricercare nel fertile, ma in questi anni forse poco qualitativo, terreno del melodic rock a cui aggiungono una buona dose di pop rock, trademark della band, a rinvigorire il tutto.
Così a partire dalla radiofonica Alive, passando per i due già conosciuti singoli citati sopra e correndo veloci sulle note di brani Pop radiofonici come Done Doin’ Me, Not Afraid To Fall o brani più melodic rock oriented come Give It All, Broken, un pizzico di melodic funkie con Living Out Loud, senza dimenticare il must have della bella ballata di turno a titolo Love Comes si arriva veloci e con piacere a chiudere l’ascolto sulle note della semi ballad Doesn’t Feel That Way.
Squadra che vince non si cambia e se forse anche gli Honeymoon Suite hanno vinto meno di quello che avrebbero meritato e ormai sono in ritardo sui tempi per segnare il punto della vita, ma diciamo che è tutto il genere ad essere in ritardo ormai, dimostrano con questo Alive di avere ancora i numeri per fare bene in questo inflazionato genere.
Dal loro ci mettono un lato Pop rock che gli si addice unito ad una produzione di livello. Se dalla vostra avete un lato Rock tendente al morbido allora questo è un album che non dovete farvi sfuggire!
Revolution Saints – Against The Winds – Recensione
09 Febbraio 2024 4 Commenti Paolo Paganini
genere: Aor
anno: 2024
etichetta: Frontiers
I Revolution Saints nascono nel 2015 da un’idea di Serafino Perugino (presidente di Frontiers Records) impressionato dalle capacità canore di Dean Castronovo fino ad allora conosciuto principalmente come ottimo batterista di svariate band del panorama rock internazionale (Journey, Bad English, Hardline solo per citarne alcune). Da tempo infatti il nostro aveva iniziato a cimentarsi come voce solista su alcune canzoni durante le esibizioni live dei Journey sorprendendo e non poco gli addetti ai lavori. Affiancato inizialmente da Jack Blades (bassista dei Night Ranger) e Doug Aldrich (chitarrista di Whitesnake e DIO) nacque il progetto Revolution Saints che tra il 2015 ed il 2020 diede alle stampe tre apprezzati dischi di AOR/Melodic Rock. Lo scorso anno il cambio di formazione con l’ingresso in squadra di Jeff Pilson al basso (Dokken, Foreigner) e Joel Hoekstra alle chitarre (Night Ranger, Whitesnake) e la pubblicazione del cd Eagle Flight. Ad un anno di distanza esce il nuovo capitolo di quello che da progetto estemporaneo sta diventando una solida realtà.
Le undici songs di cui è composto il nuovo lavoro da studio si basano su un corposo e validissimo AOR compatto e vigoroso con alcune incursioni su territori più hard rock che non fanno che confermare quanto di buono ascoltato fino ad oggi. Brani come Against The Winds, Changing My Mind (perla dell’album) e No Turning Back sono delle vere e proprie Hit che faranno la felicità dei fan dei Journey. Gli amanti delle ballate struggenti troveranno immenso godimento ascoltando Can’t End It Right Now e Show Me Your Light dove emergono tracce degli immensi The Storm. Se invece sentite la necessità di sonorità più robuste Fall On My Knees, Will I See You Again e Save All That Remains faranno al caso vostro.
Tirando le somme possiamo parlare di un ottimo disco a suo modo variegato che si farà apprezzare sotto ogni punto di vista, dalle composizioni alla produzione, dalla indiscutibile perizia tecnica dei musicisti all’eterogeneità degli stili proposti. In un contesto inflazionato da una miriade di uscite anonime i vecchi leoni Dean, Jeff e Joel fanno valere la propria esperienza piazzando un disco di indubbio valore che troverà sicuramente unanime consenso tra i rocker che ci seguono su queste pagine.
Lucifer – Lucifer V – Recensione
08 Febbraio 2024 2 Commenti Giorgio Barbieri
genere: Hard Rock/Heavy Metal
anno: 2024
etichetta: Nuclear Blast
Ma come, direte voi, i Lucifer su Melodic Rock.it? Ma sì, cari i miei mollaccioni, non abbiate paura, nessuno vuole spaventarvi con grugniti o chiese incendiate, la band formata nel 2014 da Johanna Sadonis, che ora oltre ad aver ripreso il proprio cognome originale Platow, ha assunto anche quello del coniuge, il tentacolare Nicke Andersson che conosciamo soprattutto per essere il fondatore di Entombed e The Hellacopters, non ha nulla che vedere con gli estremismi sonori che un monicker tale potrebbe far presagire, anzi, ultimamente è diventata una macchina da canzoni “orecchiabili”, pur mantenendo quella tenebrosità di fondo nelle atmosfere e nei testi, ma avvicinandosi sempre di più al lato hard rock e relegando a qualche riff il lato doom, ma procediamo con ordine.
L’attesa per questo quinto capitolo nella discografia della band oramai svedese a tutti gli effetti, seppur Johanna sia Berlinese, era stata resa incandescente per quanto mi riguarda, dall’uscita di quattro singoli, dei quali il primo addirittura lo scorso 17 Maggio 2023, tutto lasciava presagire una sterzata ancora più delineata verso l’hard rock settantiano, rispetto al già vintage “Lucifer IV” e se tanto mi dava tanto ci si trovava di fronte ad una sottospecie di capolavoro, ma adesso che l’album è uscito, le premesse sono state mantenute? In parte, sicuramente la qualità è alta, quello che manca è la voglia di stupire e mi spiego, in questo quinto lavoro i Lucifer si adagiano su di un hard rock settantiano levigato, dove la ricerca della melodia è sempre in primo piano e l’effetto sorpresa che in molti casi negli album precedenti ha fatto sì che i pezzi risultassero meno prevedibili della norma, qui viene diluito dalla voglia della band di toccare generi quali il blues, la nwobhm, il rock’n’roll, addirittura il garage, che implicano una certa semplicità, cosa che peraltro gli è venuta discretamente bene. ‘Fallen angel’ parte col botto, trainata da un riff appunto figlio della nwobhm e non perde un grammo di energia lungo tutti i poco più di tre minuti di durata, ma a far ritornare i Lucifer più luciferini, e la ripetizione è voluta, ci pensa quello che è stato il secondo singolo pubblicato, “At the mortuary” che inizia con un sinistro rintocco di campane sostenuto da un riff sabbathiano fino al midollo, salvo poi evolversi in hard rock di facilissima lettura e se ‘Riding reaper’ si mantiene su coordinate abbastanza canoniche, tanto da risultare il brano più inoffensivo dell’album, ecco arrivare ‘Slow dance in the crypt’, fumoso blues che da l’impressione di trovarsi in un malfamato bar di periferia, dove la musica del diavolo la fa da padrone e qui si comincia a stagliare quella macabra sensualità, seppur resa solare dal ritornello, a mio parere è questo terzo singolo a rappresentare il punto più alto di “Lucifer V”. Subito dopo, sorretta da un riff metalloso, arriva ‘A coffin has no silver linings” il primo singolo, dal titolo geniale, dall’andamento quadrato, ma tutto sommato ancora facilmente fruibile, sfrontato è l’aggettivo che mi viene in mente all’ascolto del quarto e ultimo singolo ‘Maculate heart’, che flirta con il sound anni sessanta e lo frulla con i Blue Oyster Cult, ecco, la band di Eric Bloom, con le dovute proporzioni, è quella che più ricorre nel sound dei Lucifer, aggiungendo pulsioni quasi pop rock ad un sentore di zolfo, cosa che ha caratterizzato tutta la sontuosa carriera degli autori di “Cultosaurus Erectus” e se ‘The dead don’t speak’ si insinua intrigante con un incedere tra il garage e l’hard rock, ‘Strange sister’ squarcia l’aere con un hard rock ammiccante, tagliato in due da un’intermezzo lugubre , ma pur sempre con un fondo di positività, infine arriva la drammatica e seducente chiusura con ‘Nothing left to lose but my life’, che si basa ancora su un blues ammiccante e ricco di intensità e che sfocia in un crescendo in cui il brano va a perdersi.
Per chi ha seguito i Lucifer fin dal primo album, probabilmente questo album rappresenterà qualcosa di banalotto o tuttalpiù immaginabile, mentre chi apprezza il loro lato smaccatamente rock, troverà qualcosa con cui trastullarsi al di fuori dei canoni e dei generi trattati qui, per quanto mi riguarda, pur non gridando al miracolo, apprezzo la capacità della band di miscelare sapientemente le tematiche occulte con una musica a tratti vicina al pop rock, senza sfigurare e apprezzo ancor di più la produzione volutamente vintage, con suoni crudi e diretti, senza trigger e ammennicoli vari che purtroppo, in molti casi, mamma Nuclear Blast impone ai propri gruppi, quindi, ben vengano album come “Lucifer V” che ci fanno riscoprire il rock vero e viscerale!
Nubian Rose – Amen – Recensione
31 Gennaio 2024 0 Commenti Giorgio Barbieri
genere: Hard Rock
anno: 2024
etichetta: Livewire/ Cargo
Devo ammettere che non conoscevo i Nubian Rose, non solo perché non si facevano sentire dal 2014, quando pubblicarono “Mental revolution”, ma anche perché, a detta di tutti, facevano un genere che non è propriamente nelle mie corde, ma ascoltando “Amen”, loro terzo album, devo chiedere venia e prostrarmi sui ceci, perché non si tratta assolutamente di un classico e molte volte scontatissimo hard melodico, o meglio, in parte, ma siamo di fronte ad un’opera di magniloquente hard’n’heavy, che senza essere stucchevole, si diletta a esplorare il prog metal più diretto e l’epic più arioso, insomma qualcosa di fresco, che mi ha lasciato davvero stupito.
Fin dall’opener ‘Memorial’ si intravedono le qualità dei Nubian Rose, con la voce di Sofia Lilja a dettare legge e la chitarra di Christer Akerlund a ricamare fraseggi notevoli, subito doppiata da ‘Dramatic day’, particolarmente “sentita” da Sofia, la quale parla del proprio funerale, quindi non proprio un argomento tipico di lidi melodici, musicalmente questo pezzo è un bel heavy rock, con un incedere ricco di tensione, la cosa che lascia spiazzati è la mancanza di un ritornello nella canzone, cosa che la rende sicuramente meno scontata, togliendo quel fastidioso sentore di “già sentito” che oramai nell”hard’n’heavy (purtroppo) spopola e anche la successiva ‘Break down thew walls’ non è da meno, mantenendo una vigoria heavy, ma con un’apertura catchy non smielata e un assolo che parte malmsteeniano per poi finire ricalcando la melodia portante; ma, la canzone che più di tutte mi ha conquistato è ‘Lost in the mist’, brano che esce ancora di più dagli schemi rispetto a ‘Dramatic day’, lungo (quasi dieci minuti!), ma appassionante e vigoroso quanto basta, per referenze, ascoltate il riffone che tira fuori Christer, quasi a ricordare la sua collaborazione in precedenza, sempre nei Nubian Rose, con Torbjörn Weinesjö, ex ascia dei prog/epic/doomsters Veni Domine, non per niente qui si sfiora il prog metal, ma con una struttura drammaticamente epicheggiante.
Particolarmente emozionante è ‘Red sky’, quattro minuti e mezzo di crescendo nella quale Christer affianca per la prima volta Sofia alla voce, seguita a ruota da un altro episodio particolarmente riuscito come ‘Desert night’, che dopo un inizio arabeggiante, si dipana in un hard rock quasi zeppeliniano figlio del poco apprezzato, non da me sia chiaro, “Strange and beautiful” dei Crimson Glory, sul quale si staglia imponente la potenza di Sofia, ci sono anche pezzi “normali” in questo album, ma non per questo il valore del platter viene sminuito, ‘Running’ è sicuramente più classica, seppur introdotta da un tempo quasi funky-disco anni settanta, ‘Hard road’ e ‘Bright lights’ si rifanno ad un hard’n’heavy più lineare, sorrette da rocciosi riff di scuola priestiana, soprattuto la seconda, mentre in fondo troviamo la cover di ‘Gonna get close to you’ di Lisa Dalbello, rifatta poi dai Queensryche sul magnifico “Rage for order” e purtroppo qui arriva a mio parere, una piccola nota dolente, posso infatti anche apprezzare il fatto che la band cerchi di farne una sua versione, ma qui si perde tutto il pathos e la grinta che il brano aveva fin dalla sua prima pubblicazione, peccato, anche se di certo ciò non influisce sul giudizio finale, che è estremamente positivo.
P.s.
Nota finale che riguarda noi scribacchini, che molte volte ci troviamo alle prese con promo sheet che non fanno altro che glorificare l’album presentato (a volte anche ingiustificatamente), mentre non danno molte informazioni che invece a noi imbrattatoti di pagine web, possono risultare importanti ed è così che vedrete nella casella riguardante la line up, i soli nomi di Sofia e Christer perché, ad oggi, non sappiamo se ci siano o no altri musicisti, che magari non fanno parte della band, ma perlomeno hanno registrato il disco, ecco, magari un po’ più di attenzione a questi dettagli e un po’ meno righe di autoglorificazione gratuita, sarebbero ben accetti…
Robert Hart – Circus Life – Recensione
29 Gennaio 2024 0 Commenti Vittorio Mortara
genere: Hard Rock
anno: 2024
etichetta: Escape
Parte la prima traccia e… Accidenti, devo aver sbagliato cartella! Questo è un disco degli FM… Fa vedere… No! E’ proprio Robert Hart! Ah ecco! C’è Overland ai cori… Vediamo “Stone heart”… cribbio! Ma questa cos’è? Una outtake da un disco dei Bad Company? E anche la successiva “Blame it on me” gronda hard blues da tutti i solchi. Ma il raffinato AOR di “Cries and whispers”? E le contaminazioni pop e funky dello straordinario “Pure”? Dove sono finiti? Aspetta, qualcosa fa capolino in “I’m on your side”… però finisce per assomigliare un po’ troppo agli ultimi lenti degli FM… Mannaggia alla voce di Overland! Il tocco del plettro (e della penna) di Steve Morris è riconoscibilissimo su “I’ll take the bullet”, pezzo che non avrebbe sfigurato sull’ultimo Heartland. Il rockaccio della cattiva compagnia la fa da padrone anche su “Lay me down easy” e sul classico giro di blues che costituisce “Right here, right now”. E, anche se il mezzo arpeggio iniziale mi aveva fatto sperare il contrario, pure “Too much time on my hands” si infila fra i Bad Company e gli FM post “Tough it out”… Molto più gradevoli le movenze sexy e raffinate di “Bring on Tomorrow”, di gran lunga la canzone più bella del lotto! Bello anche il ritornello sornione di “That was the day”. E se volete gustare, finalmente, un po’ di sano AOR in salsa worchestershire, buttate giù in un solo fiato “Wrong side of love” perché poi si chiude con “The time of our lives” navigando ancora una volta su territori bluesati.
“Circus life” è la summa dell’hard rock britannico degli ultimi 30 anni. A partire dai super musicisti che partecipano al progetto sia in vece di strumentisti che di compositori. E’ un album che piacerà un sacco a tutti i fans della Bad Company e degli FM meno AOR. Ed al vostro redattore è piaciuto? Non tantissimo. Mi sono mancati la leggiadria compositiva e le molteplici influenze che mi avevano esaltato sui due precedenti solisti di Robert. Ma devo anche ammettere che, ultimamente, non mi piace praticamente nulla… Il voto prendetelo, dunque, con le pinze e giudicate voi… Buon ascolto!
Notorious – Marching On – Recensione Breve
29 Gennaio 2024 0 Commenti Giulio B.
genere: SLEAZE METAL
anno: 2024
etichetta: Pride & Joy
Seconda uscita discografica per i Notorious tramite Pride & Joy Music. La band di Bergen (Norvegia) pesca a piene mani da gruppi come Tigertailz, W.a.s.p., Britny Fox e, in alcune sfaccettature, ai primi Motley Crue.
Suddivido la recensione in aspetti positivi e negativi.
Tra gli aspetti negativi, la copertina da cui mi aspetterei un genere metal molto più pesante, una tracklist di solo otto canzoni, con la durata che non arriva a 35 minuti, escludendo il poco accattivante, per non dire trascurabile, intro.
Tra gli aspetti positivi, la particolare presenza del cantante Henrik Skar (a cui la copertina calzerebbe bene al suo genere black metal) nell’ultima traccia, e l’efficace lavoro di DiCato alle chitarre che, in alcune soluzioni neoclassiche, ricorda lo stile di Malmsteen.
Le canzoni che segnalo sono “All Night”, Ain’t No Stoppin” con la presenza di Mark Boals al supporto voce e “Remember you” con le sue variazioni chitarristiche ed un ritornello più orecchiabile.
Nel complesso, un album tosto, senza fronzoli ed omogeneo, ma piatto e con pochi cambi di passo per essere un vero e proprio…“marching on”.
Autumn’s Child – Tellus Timeline – Recensione
27 Gennaio 2024 3 Commenti Lorenzo Pietra
genere: Melodic Rock - AoR
anno: 2024
etichetta: Pride & Joy Music
Puntuale come un orologio svizzero, eccoci con l’appuntamento annuale con il nuovo album di Mikael Erlandsson e i suoi Autumn’s Child, “Tellus Timeline”. Progetto naturale proseguimento dei grandi Last Autumn’s Dream, gruppo che dagli inizi degli anni 2000 (2003 per la precisione) ci ha deliziato ogni anno con un disco di AoR e Rock Melodico di alta classe.
Cambia parzialmente la line up, infatti troviamo Pontus Akesson alla chitarra, Robban Back alla batteria, Claes Andreasson alle tastiere e Magnus Rosen, membro originario degli Hammerfall, al basso.
Il disco è come sempre ben prodotto e nonostante i tantissimi album pubblicati non si rischia l’auto plagio, infatti l’album risulta vario e con buone novità, aiutate anche dalle diverse collaborazioni sul disco; a partire dalla cantante lirica svedese Karin Funk, presente nel primo singolo Gates Of Paradise fino al duetto con il grandissimo Jim Jidhed sulla melodica Juliet. Come già indicato la collaborazione col bassista ex Hammerfall in diversi pezzi fa sentire la sua grinta.
La chitarra di Akesson primeggia su diversi brani, come la rockeggiante Here Comes The Night , dove troviamo anche un bell’assolo di tastiere, l’arena song We Are Young che non sfigurerebbe dal vivo e rappresenta perfettamente il sound di LAD + Autumn’s Child e dove ancora una volta l’accoppiata Akesson/Andreasson riesce a colpire. Il primo singolo Gates Of Paradise, con la voce del tenore Karin Funk, parte forte con un hard rock aggressivo e crescente. Il pop-rock con echi Beatles di Around The World In A Day è notevole e non scontato, l’assolo semi acustico finale ci riporta indietro nel tempo, gran pezzo. On Top Of The World ci riporta sui binari Aor, bello il piano e le tastiere che sfociano in un refrain arioso. This Is goodbye è un hard rock farcito di tastiere, classico sound scandinavo Aor dove chitarre/tastiere/cori si intrecciano in modo impeccabile. Il duetto con Jim Jidhed è il lento Juliet, dove si fonde l’Aor più classico; l’intro a la Toto, il refrain molto Journey, niente di innovativo, ma una formula per rendere un lento perfetto. Si conclude con I Belong To You, dove l’eco dei Beatles è ancora chiaro, pop con batteria secca, cori , chitarre acustiche che si fondono con un tappeto di tastiere.
IN CONCLUSIONE :
Bisogna ammettere che la formula usata in questo disco è ben riuscita, ottimi duetti, diversi stili ma sempre perfettamente in linea con l’AoR a cui ci hanno abituato Erlandsson & soci. Dategli una possibilità!
Caligula’s Horse – Charcoal Grace – Recensione
26 Gennaio 2024 4 Commenti Samuele Mannini
genere: Progressive Rock/Metal
anno: 2024
etichetta: Inside Out
Che la pandemia degli anni passati sia stata per molti un momento catartico dove ripensare la propria esistenza e guardare il mondo attraverso lenti mai indossate prima è un dato di fatto incontrovertibile. Naturalmente c’è chi ha interiorizzato la cosa e chi, come molti artisti, ha deciso di esteriorizzare questa esperienza quasi come a volerla esorcizzare ed anche i Caligula’s Horse appartengono a questa categoria. Il mood si nota già dalla copertina dove i paesaggi bucolici e solari di In Contact e Rise Radiant, vengono sostituiti da un oscuro vortice introspettivo dominato da tonalità cupe.
Naturalmente anche la musica segue questo oscuro vortice emozionale e risulta più cupa e tagliente che in passato, la chitarra è come uno scalpello che incide solchi dolorosi dentro l’anima e l’uso più marcato della voce filtrata aggiunge una sorta di sotterranea inquietudine, mentre il martellare ossessivo della sezione ritmica sottolinea il disagio che regna sovrano anche nei testi. Non che manchino le aperture più melodiche come per esempio in Vigil o Mute, ma sono più dosate che nei precedenti album e sicuramente più votate al sottolineare l’ansia di fondo che permea tutto il disco.
Per quanto riguarda la qualità siamo su livelli comunque eccelsi. L’incedere del disco mi fa lo stesso effetto che, a suo tempo, mi fece ascoltare Awake, dopo aver adorato le atmosfere di Images & Words l’assimilazione non fu facile, ma l’amore scoccò comunque. Si sentono contemporaneamente, sia la continuità artistica che il cambio emozionale e di toni compositivi, rendendo l’ascolto di Charcoal Grace una specie di scoperta, come quando torni in un luogo familiare dopo molto tempo e scorgi dettagli che mai avevi notato prima.
In sostanza dunque un disco da scoprire assolutamente, da esplorare con cautela e circospezione per coglierne tutte le numerose nuance oscure che lo caratterizzano, se poi, come me, preferite le atmosfere più aperte e solari dei due precedenti lavori, pazienza, perché comunque ciò non impedirà di gustarvi a pieno questo capitolo di una band ormai assurta al ruolo di portabandiera del moderno progressive.
The Gems – Phoenix – Recensione
26 Gennaio 2024 4 Commenti Denis Abello
genere: Hard Rock
anno: 2024
etichetta: Napalm Records
In casa Thundermother la convivenza non deve essere semplice e così circa un annetto fa tre Thundermotheriane, ossia Guernica Mancini (voce), Mona Lindgren (chitarre) e Emlee Johansson (batteria) prendono i loro bagagli e in blocco tolgono il disturbo.
Il Lupo però perde il pelo ma non il vizio, o in questo caso direi la voglia di fare musica, e così le tre ex si ritrovano e neanche da dire mettono su una band a nome The Gems e si ripresentano sul panorama musicale mondiale con l’esplicativo album Phoenix !
Album che, ancora una volta neanche da dire, riprende pari pari quello che le tre facevano nelle Thundermother, ossia del sano, sanguigno, e forse solo un pelino meno grezzo (cosa che apprezzo!) Hard Rock stradaiolo che sembra incrociare in un’orgia alcolica il sound di Kiss, Ac/Dc e Mothorhead!
La copertina decisamente fine anni ’70 che vede in un poco memorabile outfit le tre donzelle introduce invece in un lotto ben più memorabile di pezzi, 16 per l’esattezza anche se va detto che ci sono tre intermezzi ed una versione acustica del brano Like a Phoenix il che riduce in realtà, a voler ben vedere, il corposo lotto al numero più umano di dodici pezzi.
Passato quindi il primo “interlude” (Aurora) ci si lancia subito negli intenti diretti di Queens! Come a dire, gente noi siamo le Regine, ed effettivamente il pezzo gira che è un piacere. Originalità zero ma il buon gioco di squadra delle tre “Gemme” fa capire che il tutto funziona alla grande!
L’album riesce a trasmettere infatti quell’aria più “easy” (in tutti i sensi) che probabilmente si respira tra le Gems rispetto al loro recente passato, risultato ottenuto presumibilmente grazie anche all’amicizia “vera” che lega le tre al di fuori della band.
Si continua così con lo stile seventies blues hard rock di Send Me To The Wolves e sulla Mothorhediane Domino e Silver Toungue! Il concetto di “originalità pari quasi a zero” continua per tutto l’ascolto del disco ma va detto che l’album comunque si fa apprezzare con piacere grazie anche ad un lavoro veramente di livello alla chitarra per la brava Mona “DeMona” Lindgren ed alla sempre ottima voce di Guernica Mancini, mentre alla batteria Emlee Johansson mostra tutte le sue doti da rullo compressore che sono praticamente imprescindibili in un album come questo.
Senza passare al lumicino tutti i pezzi di questo Phoenix meritano una citazione l’intensa Ease Your Pain, il manifesto Like a Phoenix e la radiofonica chiusura di Fruits of my Labor.
Sarà la voglia di rivincita delle tre Gems, sarà l’amicizia che le lega ma questo Phoenix è un bell’ascoltare. Certo, prova a venderci l’acqua calda, ma lo fa almeno profumandola a dovere e presentandocela alla giusta temperatura. Consigliato un ascolto, brave Gems!










