LOGIN UTENTE
Registrati a MelodicRock.it

Registrati gratuitamente a Melodicrock.it! Potrai commentare le news e le recensioni, metterti in contatto con gli altri utenti del sito e sfruttare tutte le potenzialità della tua area personale.
effettua il Login con il tuo utente e password oppure registrati al sito di Melodic Rock Italia!
Ultime Recensioni
- Home
- /
- Ultime Recensioni
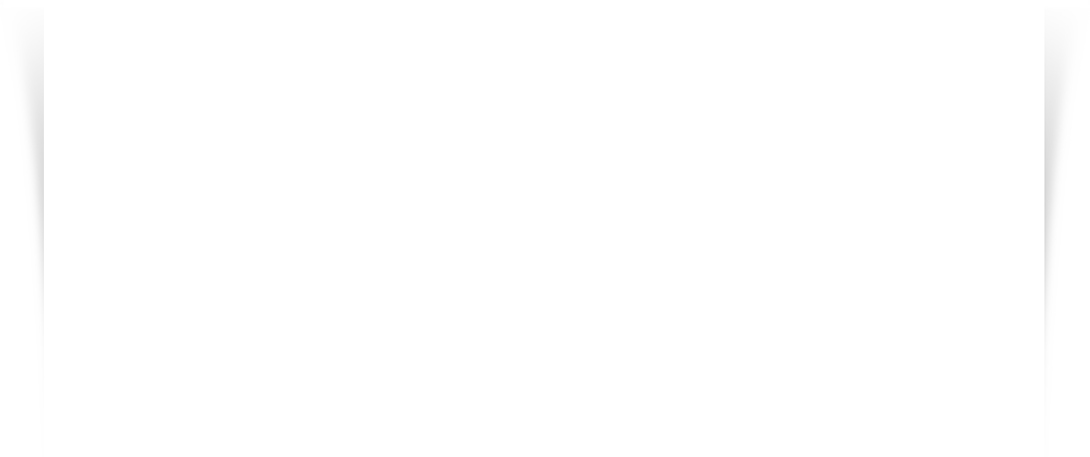
Degreed – Public Address – Recensione
05 Luglio 2023 10 Commenti Paolo Paganini
genere: Melodic Rock
anno: 2023
etichetta: Frontiers
Confesso che fin dagli esordi di Life Love Loss del 2010 rimasi fortemente colpito dalla loro musica, allora forse ancora un po’ acerba ma che nel corso degli anni non ha fatto che migliorare progressivamente e possiamo dire che con questo Public Address abbiano raggiunto il top della loro performance. La caratteristica che rende pressoché unica la loro proposta è la straordinaria capacità di unire potenti riffoni e massicce dosi di chitarre elettriche quasi metal a sontuosi tappeti di tastiere e melodie ammalianti tutto coro che lasciano senza fiato grazie anche alla graffiante e riconoscibilissima voce di Robin Ericsson. Proprio il brano scelto come singolo di lancio Big Plans riassume in pieno quanto appena detto. Chitarre granitiche e voce quasi growlin lasciano spazio ad un ritornello alla Toto (periodo Seventh One) mischiato ai migliori Def Leppard. La band continua a spingere ad alti regimi con le seguenti Who Are You (To Say) e The Way Of The World da ascoltare rigorosamente a volume elevato in macchina con finestrino abbassato e vento in faccia. Un attimo di tregua con la splendida power ballad This Is Love che con le sue sonorità classiche vi catapulterà indietro nel tempo mantenendo una freschezza e un’attualità impressionanti. Da menzionare il grande lavoro di tutti i musicisti coinvolti, nessuno escluso. Grandi assoli di Daniel Jhoansson e sezione ritmica di un altro livello il tutto prodotto in maniera pressoché perfetta. La band riprende come nulla a sfornare canzoni che ti entrano in testa al primo ascolto e così la folle corsa riprende con la magnifica Ride Along. Potremmo già ritenerci ampiamente soddisfatti di quanto sentito finora ma i Degreed non hanno alcuna intenzione di fermarsi e sia Free Again che Resist The Urge continuano imperterrite la propria ricerca della melodia perfetta da ripetere all’infinito. Piccolo grande gioiello la sognante pianistica ballad Don’t Be A Stranger sulla quale non possiamo non inchinarci e toglierci il cappello con Robin che dimostra di essere uno dei cantanti migliori in circolazione almeno per questo genere musicale. I quattro brani in chiusura non fanno altro che confermare quanto di buono detto fino a qui quindi non mi dilungherò oltremodo ad incensare la band che come avrete ormai capito è tra le mie preferite degli ultimi anni.
IN CONCLUSIONE:
Un lavoro impeccabile sotto tutti i punti di vista a cui sinceramente non riesco a trovare un punto debole. Perché non dare 95 allora direte? Beh perché sono sicuro che la prossima uscita sarà ancora migliore e la successiva ancora di più e una volta arrivato a 100 rischio di andare fuori scala! Buon ascolto e buona estate!
Mats Karlsson – Mood Elevator – Recensione
05 Luglio 2023 1 Commento Alberto Rozza
genere: AOR/Hard Rock
anno: 2023
etichetta: Sound Pollution
Chicca estiva per il chitarrista svedese Mats Karlsson, figura storica dell’hard rock europeo con una lunga militanza nei 220 Volt, che propone un nuovo lavoro ricco di collaborazioni e un sano rock d’altri tempi.
Dopo l’intro “Asteroids”, parte senza troppi complimenti “Beautiful Life”, tagliente e ritmata, dal sound gagliardo e canonico, che apre positivamente e in modo gioioso questo disco. Passiamo alla title track “Mood Elevator”, scanzonata e ritmicamente coinvolgente, dal ritornello che resta in mente, globalmente un brano ben strutturato e ben riuscito. “War Child” risulta maggiormente contemplativo e caldo, un simil lento molto sentito e introspettivo, piacevole nella sua interezza. Torniamo a ballare sulle note di “Keeping Time”, veramente rockeggiante e travolgente, semplice e diretta, chitarristicamente interessante. Arriviamo alla cover di “Big Yellow Taxi” di Joni Mitchell, inconsueta e ben riuscita in questa versione elettrica. “Kiss Of Life” è un classico pezzone hard rock, rétro, ben eseguito, dalla trama intrigante e dal solo melodico e piacevole, così come la successiva “Letters Without Signatures”, corposa e cadenzata, dal sapore molto anni ‘80. “Higher Than High” presenta una trama strumentale molto ben cesellata, a partire dai suoni ottimamente scelti, sino alla ritmica piacevole e coinvolgente. Sonorità spaziali aprono “Magic Wand”, travolgente e potente, canonico nella tessitura e gradevole all’ascolto. “Try My Love” rilassa l’atmosfera e ci porta su nuovi orizzonti, facendoci immaginare i classici paesaggi da “road trip”. Chiudiamo questo viaggio in compagnia di Mats Karlsson con “Tripping Point”, oscura e misteriosa, che ci consegna infine un lavoro decisamente interessante, a tratti con spunti originali, eseguito con la giusta convinzione e la giusta maturità tecnica: ascolto dell’estate assicurato!
Pendragon – North Star (Ep) – Recensione
03 Luglio 2023 13 Commenti Samuele Mannini
genere: Prog. Rock
anno: 2023
etichetta: Pedragon Toff Records
Per me nuovo materiale dei Pendragon è sempre un evento da celebrare, anche se qui, con soli 24 minuti di musica resta l’appetito. Comunque, taglio subito la testa al toro, le canzoni sono bellissime.
Dopo Love Over Fear del 2020 (Recensione Qui), dove si notava un recupero delle vecchie sonorità, in questo North Star si continua su quel solco, anche se naturalmente, come ormai tradizione della band, si nota una certa evoluzione ed ampliamento degli orizzonti sonori. In questi due brani (di cui uno è una suite in tre capitoli) si notano infatti forti riferimenti folk ed il tutto è pervaso da atmosfere bucoliche ed oniriche. Innegabilmente, quando ci sono da pennellare scenari eterei e pastorali (già a partire dalla copertina), i Pendragon sono dei maestri assoluti e riescono sempre a coinvolgere la più intima dimensione dell’anima fatta di sogni e poesie. Ecco appunto quello che accade nei tre capitoli che compongono la Suite North Star, 18 minuti di puro viaggio in musica, a cui segue la terapeutica ballata quasi totalmente acustica Fall Away, arricchita nel finale da un tappeto di synth che disegna scenari intangibili dove la mente vola cullata dalle note. Non so se questa direzione artistica, meno propensa al rock magari, proseguirà in futuro oppure resterà confinata a questo Ep, ma l’ascolto mi lascia totalmente appagato ed anzi, con una irrefrenabile sensazione di volerne di più, che è sicuramente segno di qualità assoluta.
Insomma, magari non consiglierei di scoprire la band proprio con questo disco, perché seppur pieno di pregi, mostra soltanto una piccola parte delle innumerevoli sfaccettature artistiche del gruppo, ma per un fan della band metterci le mani sopra è un obbligo morale e mentre i miei neuroni viaggiano lieti nell’ etereo mondo dei Pendragon, ho già l’acquolina in bocca pensando ad un nuovo full lenght…
Virgin Steele – The Passion Of Dyonisius – Recensione
03 Luglio 2023 4 Commenti Giorgio Barbieri
genere: Heavy Metal
anno: 2023
etichetta: Spv
Per me, parlare dei Virgin Steele è sempre difficile, nel bene e nel male, soprattutto da quando David DeFeis ha deciso che la band non esiste più, ma che sia diventata praticamente un suo progetto solista, con il fido Edward Pursino a fare da sparring partner e anche stavolta non riesco a fargliela passare , sono troppi i problemi di questo “The passion of Dyonisius”, diciottesimo album in studio (anche se i tre precedenti non sono propriamente degli album di inediti), come al solito incentrato su un concept ideato da David, il quale canta, suona basso, tastiere, anche la batteria e produce l’album, in pratica, escluse le parti di chitarra, fa tutto, ma come lo fa? Vediamo…
Innanzitutto, ci sono due piccoli passi avanti rispetto al precedente “Nocturnes of hellfire & damnation”, dove David riempiva i pezzi con un fastidiosissimo falsetto, cosa che in questo album fa molto meno, risultando così meno stucchevole e non c’è la drum machine, purtroppo però sono gli unici punti a favore , perché per il resto, al netto del fatto che le sessantun primavere si fanno sentire, David continua a riempire a dismisura le canzoni, persino sopra alle chitarre, le quali dal canto loro sono decisamente penalizzate in fase di mixaggio, restando in secondo piano rispetto alla voce e alle tastiere. In molti casi si sente anche l’aiuto del tremendo autotune, soprattutto in “The ritual of descent”, lunga, ossessiva e resa ancor più “faticosa” dai quasi tredici (!) minuti di durata, ecco, questo è un altro problema, la durata dell’album sfiora gli ottanta minuti per dieci canzoni e se si tiene conto che “Black earth & blood” dura poco meno di tre minuti, ci si trova di fronte a dei discreti mattoni da sopportare, resi ancora più pesanti dalle scelte sonore che penalizzano anche l’accoppiata iniziale composta da “The Gethsemane effect”, mid tempo con un discreto riff portante, che viene però seppellito dalle parti vocali al limite del sopportabile e “You’ll never see the sun again”, che ha un buon ritornello, ma i rallentamenti con annessi urletti senza senso sminuiscono il brano, e poi la batteria plasticosa, quasi finta, soprattutto nella conclusiva “I will fear no man for I am a God”, pezzo che perlomeno scorre abbastanza agevolmente, ma con le parti orchestrali e i vocalizzi a coprire tutto, insomma un vero e proprio disastro, soprattutto se si pensa ai magniloquenti dischi pubblicati almeno fino a “Invictus”. Emblematica della pochezza dell’album è “A song of possession”, che inizia con un tempo in doppia cassa e finisce ancora così dopo quasi sei minuti nei quali David fa di tutto per rendere l’ascolto ancora più noioso e dove le chitarre rimangono in secondo piano a fare quasi da comparsa, ecco, le chitarre, oltre a Josh block che usa una sette corde ma nessuno se ne accorge, che fine ha fatto Edward Pursino? Sì, proprio il protagonista di “I will come for you” o di “Weeping of the spirits”, ebbene se io fossi in lui mi sarei incazzato come una bestia nel momento in cui finivo di ascoltare il mixing definitivo, a parte il fatto che anche lui ci mette del suo a sciorinare assoli di una brevità disarmante, come in “Unio mystica (the girl with the grave deep eyes)”, ma l’effetto ‘Jason Newsted su …and justice for all’ è evidente ed è solo colpa delle scelte effettuate da David in fase di produzione. Si può salvare qualcosa dal naufragio annunciato? Forse il primo singolo “Spiritual warfare”, che al netto dei quasi otto minuti di durata e dei sibili irritanti inseriti un po’ dappertutto dal deus ex machina, almeno quando si intestardisce sui toni alti che oramai non raggiunge più, fluisce bene e da uno scossone alle mie stanche orecchie che erano abituate a ben altro quando si trattava dei Virgin Steele, ma quando anche nel pezzo più breve, ossia la già citata “Black earth & blood”, si fa fatica ad arrivare al termine, sempre a causa di suoni davvero pessimi, degli strepitii di David che vanno a coprire un cantato su registro più basso finalmente ispirato e dove addirittura non c’è un assolo, si capisce che da qui non ce la si fa ad uscirne e addirittura laddove come nella title track e in “To bind & kill a God”, le canzoni sembrano avere più carica, arriva l’infinita lunghezza a renderle davvero pesanti.
Mettiamoci il cuore in pace, David è davvero convinto che agendo così, la sua creatura possa risollevarsi da quell’abisso in cui lui stesso l’ha fatta precipitare , con il songwriting a senso unico oramai quasi (non tutto è da buttare, dai…) inaridito, con i suoi compagni ridotti a semplici mestieranti, con le sue manie di grandezza mostrate anche nelle sue tante foto che accompagnano il comunicato stampa, bisognerebbe rinchiuderlo in una stanza e fargli ascoltare la grandeur dei due “Marriage of heaven & hell”, l’epicità di “Noble savage”, la verve hard rock di “Age of consent”, la sfrontatezza di “Guardians of the flame”, la storicità di “Invictus” e dirgli, ecco, questi dischi li hai fatti tu con una band alle spalle, davvero vuoi continuare a fare scempi andando avanti per la tua strada, in solitaria, come se niente fosse? Purtroppo credo di conoscere già la risposta…
Sergeant Steel – Mister Sippi – Recensione
30 Giugno 2023 0 Commenti Alberto Rozza
genere: Hard Rock
anno: 2023
etichetta: Metalpolis
Ritorno col botto per la band hard rock numero uno d’Austria: ecco i Sergeant Steel, con il loro nuovo album e con sempre tanta voglia di stupire.
Il nostro viaggio parte con la calorosa “Down To Mississippi”, emblematica, ritmatissima e significativa, che va ad indirizzare tutto il lavoro e le sonorità presenti nel disco. Proseguiamo la cavalcata con “Please Me, Tease Me”, fortissima e serratissima, che ci fa capire senza dubbi lo stato eccellente della compagine austriaca. Puramente rock’n’roll, “Mama Didn’t Raise No Fool” è un brano alla Meat Loaf: tradizionale, corale e coinvolgente, si presenta come un brano godibile da un pubblico ampio. “Alive” strizza l’occhio alle atmosfere bonjoviane, risultando ottima nei cambi di dinamica e nelle parti solistiche. Ci tranquillizziamo un attimo sulle note della suadente “My Way”, lenta e introspettiva, consueta presenza in un album hard rock che si rispetti. I suoni si inaspriscono con “Knight’s Tale”, tostissima e pestata, molto heavy in tutte le sue sfaccettature, che riescono a farla risaltare all’interno di questo lavoro prettamente rock. “One Way Ticket From Hell” presenta una struttura e delle sonorità molto canoniche, globalmente piacevoli, non molto originali, ma che riescono a intrigare pienamente l’ascoltatore. Trasportante e crudele, “Caught In The Web” ha un tiro e un’atmosfera molto interessanti, dimostrandosi una gradevolissima sorpresa a questo punto dell’album. Secondo lentone affidato a “My Girl”, sul quale poco c’è da dire se non le solite considerazioni sui lenti intensi e ben composti. Passa velocemente la scanzonata “Rock Your Pants Off”, senza fronzoli eccessivi, leggera e coinvolgente, che ci porta alla conclusiva “Cry Out Your Heart, Baby!”, delizioso unplugged posizionato in coda come bonus track: si chiude così “Mister Sippi”, un album maturo, in pieno stile Sergeant Steel, molto leggero e piacevole all’ascolto, ennesima attestazione per questa band di genere, sempre in grande forma.
Vypera – Race Of Time – Recensione
27 Giugno 2023 22 Commenti Giorgio Barbieri
genere: Hard Rock/Heavy Metal
anno: 2023
etichetta: Frontiers
Il secondo album dei Vypera è fantastico, un vero e proprio capolavoro, un enorme tributo agli anni ottanta, senza alcuna contaminazione, con un songwriting ispirato e del tutto votato al periodo che tutti noi amiamo e che rimpiangiamo ogni giorno strappandoci le vesti, sin da quando il 31 Dicembre 1989 è finito ed è cominciato il primo Gennaio 1990…aspetta, ma qui non siamo sulle pagine di “quelli bravi”, anche perché io non ci starei, quindi, cosa sta succedendo? Semplice, per qualche secondo ho pensato che “Race of time” fosse un grande album e che potesse far breccia in quel vecchio metallaro che vi sta intrattenendo con queste righe, ma dopo circa due minuti del pezzo di apertura “Hey you”, ho capito che di cose interessanti, qui dentro ce ne sono, ma non sono molte, prova ne è lo sbadiglio partito dopo il secondo singolo “Riding on the wind” e posto che anche la fantasia, per i Vypera, latita anche nei titoli, passo alla spiegazione dell’idea che mi sono fatto sul secondo album della band di Sandviken.
Intendiamoci, l’album non è brutto, è semplicemente vecchio, anche negli anni ottanta sarebbe stato scontato, ma lì eravamo ggggiovani e ci esaltavamo anche per cose poco impegnate, per cui, chiunque cerchi un revival degli 80s senza alcuna pretesa, qui potrà trovare pane per i propri denti, per tutti quelli che, come me, fin dalla seconda metà degli anni ottanta stessi, hanno cominciato a cercare nuove vie pur continuando a tributare i classici, questo album è talmente “semplice” da risultare ingenuo e l’attenzione all’ascolto cala vistosamente. I primi due singoli posti in apertura e già conosciuti da tempo possono magari far smuovere il piedino e far urlare a squarciagola il ritornello, ma alla fine cosa resta? Un obsoleto omaggio alla decade stranominata, fatto anche con sufficienza, da musicisti sì bravi, ma che qui si limitano al compitino, d’altronde non serve essere i Dream Theater per suonare questo genere e bisogna riconoscerlo, ma con “Mary Jane” (a ridaie con i titoli già sentiti!) le cose migliorano? Beh, penso che dopo due pezzi così semplici, le cose possono solo migliorare e l’inizio sembra andare per questa strada con una partenza d’assalto e assoli al fulmicotone che sembrano uscire da un album degli Scorpions dei medi 80s e finalmente non si sentono incursioni di quelle tastierine zuccherose che affievolivano la già debole tensione nei primi due brani, “Stormwind” segue portando la tranquillità di quelle ballad semiacustiche tipiche, toh, guarda un pò, di molti album anni ottanta, un pò Europe, un pò Poison, anche qui, formalmente un pezzo fatto bene, con un’interpretazione vocale finalmente convincente, ma che sa di già sentito da chilometri di distanza, “Vicious” è un mid tempo che parte come migliaia di altri pezzi di heavy melodico, con assoli plurimi ad introdurre un andamento sostenuto, ma perlomeno il testosterone qui sale e i break disseminati lungo il brano danno una sferzata positiva e magniloquente, “No place for a dreamer” è un roccioso metal, con cori a-la White Lion e stacco simil funky, che si chiude in un crescendo di ripetizioni e up tempo finale, insomma qui dentro ci sono tante cose e potrebbe risultare la canzone più interessante se solo quelle idee fossero un pò più protratte, invece di essere solo accennate. Pensate che le cose stiano migliorando? Illusi, “Trying hard to run away” è un class metal talmente scontato, da farmi prevedere lungo l’ascolto cosa avrebbero suonato e cantato i Vypera, l’inizio sincopato di “Fool’s game” (di nuovo…ma si sono studiati i titoli di altri gruppi?) fa ben sperare, poi entra tutta la band e si cade nel prevedibile hard’n’heavy, addirittura qui con un ritornello neanche particolarmente catchy, qualcosa si muove con “Speedin'” e il suo inizio degno dei Vicious Rumors d’annata, peccato che qui non ci sia il compianto Carl Albert e si sente e neanche Geoff Thorpe, altrimenti un testo come “Speedin’, faster than the speed of light”, fiera del trito e ritrito, non sarebbe neanche stato pensato, perlomeno dopo urletti glam che fanno abbastanza sorridere, il pezzo si chiude con una serie di assoli centrati e ficcanti, per “Daytona” il discorso potrebbe essere lo stesso di “Fool’s game”, un buon inizio ispirato e “sentito”, viene vanificato da un ritornello simil aor, ma che di aor ha solo la melodia, per il resto c’è poca ispirazione e una voce che non cambia mai registro. Vi ricordate che i Vypera, praticamente nello stesso momento dell’anno scorso hanno pubblicato il pur buono “Eat your heart out”, non un capolavoro, ma un bel disco di power metal made in USA, ecco, “Slave to love” (e beh, ma allora lo fate apposta!) è l’unico brano che avrebbe potuto stare su quell’album, vigoroso, incalzante, con dei riff finalmente rocciosi e un cantato che, seppur non cambia nemmeno stavolta, almeno si rivela azzeccato e fa chiudere l’ascolto di “Race of time” con un sorriso.
Cosa si può aggiungere in conclusione che non sia già stato detto? Poco in realtà, come un “collega” mi ha detto in via informale, sembra che “Race of time” sia composto da canzoni che inizialmente sono state estromesse dal primo album ed in effetti è difficile pensare che un gruppo possa avere un songwriting particolarmente ispirato se è “costretto” a pubblicare un album a distanza di un anno dal precedente, così facendo, non si potrà mai avere un disco che non sia un minimo stato pensato e allora direte voi, cosa si pretende da un gruppo che suona hard’n’heavy, anche l’ispirazione? Beh, ragazzi, le domande da farsi sono altre, devo spendere 20 eurilli per avere la scialba copia della copia della copia di un gruppo class anni ottanta? No! Devo continuare a dare voce a tutto questo revival, portato avanti soprattutto in Scandinavia, da chi in quegli anni non era nemmeno nato e che, sinceramente ha meno sussulti di un manto autostradale appena rifatto? Ancora no! Voglio divertirmi , magari in maniera spensierata? E allora ci sono gli originali degli 80s, che oltretutto per chi non avesse certi album nella propria discografia, vengono via ad un prezzo decisamente più contenuto. Questa politica delle pubblicazioni “a cottimo” non porterà a niente di buono, saturerà il mercato, di suo già inflazionato e farà scendere il livello di attenzione dell’ascoltatore verso punti sempre più bassi, è questo quello che vogliamo? Ai posteri l’ardua sentenza, diceva un certo scrittore bravino…
Midinite City – In At The Deep End – Recensione
23 Giugno 2023 1 Commento Giulio B.
genere: Melodic Hard Rock
anno: 2023
etichetta: Pride & Joy
Sono passati sei anni dalla prima uscita discografica, da me recensita, e siamo già al quarto album dei Midnite City che escono con “In at the deep end”, autoprodotto, mixato da Chris Laney e masterizzato da Classe Persson. La formula magica non cambia come anche i “druidi” compositori, i quali ripercorrono le stesse coordinate musicali delle precedenti tre uscite, ricche di tastiere e melodie ficcanti, come anche la copertina che strizza visibilmente l’occhio al nome della band.
Si parte con l’intro spaziale “Outbreak” che innesca “Ready to go”, dove già il titolo parla da solo; ebbene sì, la canzone ha la carica perfetta per partire con la voglia di ascoltare l’intero album. “Someday” è il primo singolo che trasuda di “Bang bang” (l’inciso è molto simile) dei Danger Danger; la struttura colpisce il bersaglio nel cerchio più piccolo.
Apriamo un cioccolatino dolce? “Hardest heart to break” è una semi-ballad corredata di tocchi sopraffini di tastiere e un ritornello che resta impresso.
A proposito di tastiere, “Good time music” raggiunge altissimi picchi di frizzante melodia, una delle canzoni più fresche dell’intero album che abbraccia i Poison del periodo festaiolo.
Le canzoni scorrono che è un piacere. “All fall down” marca ancora il territorio e fa da apri pista al singolo che spezza gli equilibri; “Girls gone wild” è idealmente il salto perfetto dal trampolino che non fa schizzi all’ingresso in acqua. Applausi a scena aperta per una canzone che, probabilmente, era mancata nelle precedenti uscite discografiche di Rob Wylde e soci.
Riferimenti chitarristici cari ai Def Leppard per la bellissima “Beggining of the end” arricchita da quei tocchi keys che ornano ulteriormente il pezzo. Spostiamoci poi al lento “It’s Not Me It’s You” che, come base, ha delle note che mi riportano allo splendido lento “Rules of the game” firmato da Palace e che, nei cori e nel lavoro al basso, fa ancora la rima alla band di Joe Elliot. “Raise the dead” è la più vigorosa del lotto, caratterizzata da un “campanaccio” che accompagna il brano, mentre “Like There’s No Tomorrow” chiude degnamente un lavoro senza sbavature.
Heart Line – Rock’n’Roll Queen – Recensione
22 Giugno 2023 1 Commento Vittorio Mortara
genere: Hard Rock/Class Metal
anno: 2023
etichetta: Pride & Joy
Quando recensii il primo lavoro degli Heart Line, dissi di aver scorto nella band i germi per un futuro roseo, a patto che i transalpini affinassero alcuni fondamentali caratteristiche della musica che propongono. Beh, devo dire che questo nuovo “Rock’n’Roll Queen” è un piccolo ma deciso passo avanti al debutto. Innanzitutto i garcons hanno decisamente attenuato le smancerie troppo AOR per dedicarsi con più convinzione al class metal. Le chitarre sono le assolute protagoniste del sound, con assoli sempre azzeccati e suonati con discreto gusto. La produzione è decisamente migliorata: i suoni sono più puliti ed i piani sonori ben definiti. La voce di Emmanuel è decisamente piacevole, anche se rimangono scorie di una pronuncia non perfetta e di una mancanza di una buona preparazione tecnica. Insomma, l’album è più che ascoltabile, soprattutto dalla seconda volta che lo si mette su. Perché la prima potrebbe lasciare un po’ indecisi…
Pezzi forti del disco sono senz’altro il primo terzetto di canzoni: la classy “I am the night”, la tosta “Till the end of times” e l’ottantianissima “Callo f the wild”. Gradevole la semi ballad “The last time” che molto deve ai Signal di Mark Free, mentre la title track non è esattamente il pezzo che avrei scelto come apripista. “Living in my dreams” alterna parti sussurrate a crescendo dinamici con discreta qualità. “Hard to believe” punta tutto sull’orecchiabilità” del refrain. Le ballate continuano a non essere il punto di forza della band, ma “Call me”, zeppa di clichè del genere, non è poi così male. Purtroppo gli ultimi quattro pezzi presentano una qualità decisamente calante: il songwriting si fa banalotto, Shaydon Creis mostra tutte le sue carenze tecniche (non fisiche!) e si finisce per annoiarsi un pochino.
La seconda prova discografica per un gruppo è sempre decisiva per il suo futuro. Qui i ragazzi d’oltralpe non fanno il grande salto verso l’Olimpo. Ma un saltino lo fanno comunque, con piccoli miglioramenti in tutti i settori del loro lavoro. Io li promuovo ed incoraggio. L’immediatezza delle composizioni non è ancora il loro forte, ma mi pare che ci stiano lavorando bene. Mi sentirei di consigliar loro di osare un briciolo di personalità in più… vediamo alla prossima.
Fatal Vision – Twice – Recensione
21 Giugno 2023 0 Commenti Vittorio Mortara
genere: AOR
anno: 2023
etichetta: Pride & Joy
Ad un anno di distanza dal debutto “Once” arriva sugli scaffali la nuova opera dei canadesi Fatal Vison a titolo, ovviamente, “Twice”. Non cambia la formazione del gruppo né manca lo stuolo di collaboratori ed ospiti di rango. E, ahimé, non cambia neppure la formula proposta. I nostri confezionano una manciata di pezzi dallo stile variegato che va dal westcoast sound all’aor più leggero con una discreta perizia. Non male neppure la produzione. Però, esattamente come nell’album precedente, nessuna canzone è veramente memorabile. Secondo me principalmente a causa del timbro del solito Simon Marwood, assolutamente fuori posto nel contesto, che finisce per rendere poco attendibile il risultato finale.
Ritengo che una disamina accurata dei singoli brani sia piuttosto superflua e mi limito a segnalarvi l’AOR brillante di “In my fantasy”, il lento malinconico “End of the dream”, la sbarazzina “Time has left usa s strangers”, il tributo nel titolo e nelle movenze di “Welcome to my night mare” al maestro Alice Cooper e la pianistica “The last summer night”.
All’uscita del primo disco nutrivo la speranza che i nostri prendessero una direzione diversa, in modo che la particolare voce di Simon potesse contare come una marcia in più. Purtroppo “Twice” è la fotocopia di “Once” con i suoi pregi ma anche con tutti i suoi difetti. Svanito l’effetto sorpresa resta un po’ troppo poco da dire.
Lukather – Bridges – Recensione
16 Giugno 2023 2 Commenti Nico D'andrea
genere: Rock
anno: 2023
etichetta: The Players Club/ Mascot
Cosa si nasconde dietro il sorprendente cambio di monicker di uno fra i più grandi chitarristi del mondo ? Forse un atto di coerenza verso il marchio Toto che con il definitivo ritiro dalle scene di David Paich non ha più motivo di esistere.
Così a distanza di un anno dalla sua pubblicazione il Live “Toto With A Little Help From My Friends” suona oggi come un (pregevole) epitaffio.
“Luke” preannuncia così questo “Bridges” come una sorta di ponte tra il Toto sound e la (moderata) sperimentazione dei lavori a nome Steve Lukather.
Alla prova dell’ascolto l’album mantiene in parte quanto promesso e si snoda con buona disinvoltura tra reminiscenze Toto (When I See You Again) , sonorità più moderne (Someone) e qualche (al sottoscritto poco gradita) concessione Beatlesiana…frutto magari delle recenti frequentazioni con l’amico Ringo Starr.
Il pre-chorus nel coinvolgente shuffle di “Not My Kind Of People” ne è un esempio lampante.
La scintilla non sempre si innesca ma con “All Forevers Must End” Steve Lukather ricorda a tutti cosa significhi scrivere una grande ballata…per ripetersi poi con “Take My Love”, un pezzo dove esce la viscerale anima blues del chitarrista americano.
“Burning Bridges” e “I’ll Never Know” sono le altre vette del disco.
Il denominatore comune che sposta decisamente l’asticella verso l’alto è però il solito strepitoso Guitar Work che per varietà stilistica vale inequivocabilmente l’acquisto dell’album.
Il tono della chitarra di “Luke” è sempre perfettamente riconoscibile, con gli assoli come assoluti highlights di ogni singolo brano.
A livello compositivo “Bridges” è un passo in avanti rispetto al precedente “I Found The Sun Again” e (per restare in famiglia) non molto distante dal bellissimo “Denizen Tenant” dell’amico Joseph Williams.
Insomma altro centro per la sussidiaria di Mascot “The Players Club” che fa ormai del proprio nome un claim e una garanzia.










